Repubblica 28.6.07
Cosa faceva Freud alle donne
Lo psicoanalista e il sesso femminile
di Nadia Fusini
In un libro di Lisa Appignanesi e John Forrester le prime amiche e pazienti, i numerosi triangoli amorosi e professionali
La figlia Anna, i rapporti con Lou Salomé, Marie Bonaparte, la Deutsch
Vi avverto: è rozzo il piacere che si ricava dalla lettura di questo libro Sigmund Freud e le sue donne (La tartaruga Ed., pagg.524, euro17,50), scritto in modo competente, ma piatto, da Lisa Appignanesi e John Forrester, quest´ ultimo accademico, professore di Storia e Filosofia a Cambridge, e la prima scrittrice e conduttrice di programma televisivi e artista a quanto pare a tutto campo. Né brilla la traduzione di Ester Dornetti; mancanza di lustro che non le si può addebitare (alla traduzione, intendo), in assenza di luce originale. Il libro è stato scritto nel 1992, anno in cui per i tipi di Laterza uscì in Italia un altro studio sullo stesso tema, dal titolo Psicoanalisi al femminile, a cura di Silvia Vegetti Finzi; un libro scintillante per passione, dove comparivano per lo più le stesse protagoniste, ma non come «donne di Freud». Nel libro italiano c´erano Anna Freud e Sabine Spielrein e Marie Bonaparte e Lou Andreas-Salomé e Helen Deutsch e Karen Horney e c´era pure Melanie Klein, e si arrivava fino a Francoise Dolto e Luce Irigaray - perché il criterio non era che da Freud le donne che si erano dedicate alle psicoanalisi fossero state "toccate" con mano. Mentre qui, nel libro inglese, intendo, si privilegia un´idea di conoscenza che piacerebbe all´incredulo Tommaso.
Scherzi a parte, le donne di cui parlano Appignanesi e Forrester sono le prime amiche e pazienti del dottor Freud, compresa la figlia devota, e tra le pazienti e le discepole quelle che si trasformarono poi in colleghe. Non c´è invece Melanie Klein, e giustamente: lei stessa non vorrebbe certo rientrare sotto il cappello «le donne di Freud» - la sua indipendenza ne soffrirebbe.
Nella prefazione alla ristampa inglese del 2005, che accompagna l´attuale versione italiana, si sottolinea come il libro sia stato scritto «nel secolo di Freud», un secolo ormai superato; ma entrambi gli autori si dichiarano certi che le "donne di Freud" non smetteranno di intrigare chi nel nuovo millennio ancora abbia memoria di quell´avventura straordinaria che è stata (è ancora?) la psicoanalisi. Condivido con loro tale certezza. E malgrado il mio appunto iniziale, consiglio di leggere il libro.
Ma vi prego, non lasciate che a soddisfarsi sia semplicemente il gusto del pettegolezzo. So bene come l´orecchio si delizi accostandosi a quella specie di confessionale che è il lettino psicoanalitico. La psicoanalisi, dopo tutto, che altro è, se non un modo differente di usare il letto?
Certo, a leggere una dietro l´altra le vite delle donne che a vario titolo hanno contribuito all´invenzione della psicoanalisi, fa impressione osservare quali legami ambigui si stringessero tra maestro e discepole e pazienti e allieve. Più che legami, nodi. Il solo modo di legarsi, forse.
Non è soltanto con Jung e Sabine Spielrein che Freud crea un triangolo. Si ripete tra lui, l´allievo Ernst Jones e la moglie di lui Loe, l´ebrea ricca e intelligente e invalida. E tra Tausk e Lou Salomé e di nuovo tra Tausk - Helene Deutsch e sempre Freud.
Per non parlare dei nodi che la figlia Anna, Anna-la-Santa, Anna-Cordelia, tesse non solo con il padre; ma con Dorothy Tiffany Burlington, ricchissima ereditiera americana, la quale viene in Europa per curarsi lei e i figli e diventa la compagna di Anna, la quale prende in cura i figli di lei, che si ritrovano la medesima donna nelle funzioni di terapista, insegnante, madre e compagna della madre. I risultati sono che Bob continua a soffrire di depressione e ne muore a cinquantatré anni e Mabbie si suicida a cinquantasette anni. Non male, potreste dirmi.
Colpisce, inoltre, quanto breve fosse l´apprendistato: Helene Deutsch è in analisi da appena tre mesi, quando Freud le manda un paziente, Tausk. Il quale, sarà un caso, si suiciderà.
Ruth Mack Brunswick avrà anche avuto doti naturali, ma aveva appena iniziato il tirocinio quando Freud le mandò un paziente illustre - l´uomo dei lupi. Con grande invidia e nessuna gratitudine da parte di Melanie Klein, che sarebbe stata più adatta. Anche così Freud esercitava il suo potere.
La cura durava - beati loro! - pochi mesi. Tre mesi di terapia con il dottor Jung e Sabine Spielrein guarisce. Marie Bonaparte va una prima volta per sei mesi, poi uno o due mesi l´anno, finché Freud muore. E da pazienti si diventa amici in un momento. E il padre fa l´analisi alla figlia, la madre al figlio, le mogli convincono i mariti, e i mariti le mogli a farsi analisti. E ci si prestano soldi e favori senza pregiudizi. Come in una saga disordinata e incoerente e immorale.
Pure, non fermatevi a gustare soltanto queste emozioni; ancora più forte è l´emozione di incontrare una per una le "donne di Freud", le quali sono un insieme di creature tutte davvero molto interessanti. E il vero modo di incontrarle è nel pensiero, nel modo libero in cui, con Freud e dopo Freud, continueranno a lavorare in una stanza, dietro a un letto.
Perché, se all´inizio del libro il lettore si chiede: ma che gli fa alle donne Freud? - andando avanti viene piuttosto da domandarsi: ma che ne fanno loro di Freud? e della psicoanalisi? Ne sono le vestali? O la trasformano?
Per rispondere a questa domanda si può tornare all´altro libro che citavo, quello di Laterza. Rimanendo invece a questo, non mancheremo di notare come affiori in tutte loro una lingua dell´origine della psicoanalisi, una specie di intonazione primitiva, che in Freud, grande, sommo scrittore, non avevamo colto. Le sue allieve non gli sono pari: neppure chi tra di loro vanta un pedigree letterario di eccellenza, come Lou Andreas-Salomé, la quale giunge a scuola da Freud dopo Nietzsche. Freud la accoglie a braccia aperte, con un fervore e un riconoscimento che crescono in proporzione alla quantità e qualità degli uomini che Lou ha già sedotto. La quale Lou, come la Lulù di Wedekind, sarebbe pronta a dire: «se degli uomini si sono uccisi per me, questo non diminuisce affatto il mio valore». E Freud senz´altro risponderebbe «semmai lo aumenta», assecondando così una certa idea del "femminile", che non solo in Wedekind risuona.
E´ un Freud domestico, questo, preso tra le sue donne, ripeto. Alle quali chiede di impegnarsi nella domanda da lui stesso inevasa «Was will das Weib?» E loro provano a rispondere.
Helene Deutsch si impegna a comprendere il continente oscuro della femminilità con l´arma dell´"invidia del pene" - considerato come un dato puro e semplice, fino ad apparire come l´apologa reazionaria di un masochismo femminile, diagnosticato da Freud e in quanto tale inattacabile. Joan Riviere, invece, si accanisce a definire la natura essenziale della femminilità come un bene che si fonderebbe sulla fase orale del succhiare - capezzolo, latte, pene, seme, bambino. Quanto a Marie Bonaparte, in tutto e per tutto principessa (del pisello) e fanatica di Freud, si fa spostare il (la in questo libro) clitoride più vicino alla vagina, impegnata com´è in una lotta impari contro la propria frigidità.
Evidentemente, i colloqui con il maestro non la distraggono da più drastici interventi. E ascolta non tanto le interpretazioni dell´amica Ruth Mack Brunswick, quanto i consigli che le offre sulle tecniche di masturbazione.
Combattono contro malattie e nevrosi che hanno a che fare con questioni sessuali piuttosto semplici, diciamo così: questioni di clitoride e vagina e pene, come e dove collocarli rispetto al piacere. (E´ di là da venire una differente attenzione della psicoanalisi, che ci mette piuttosto uomini e donne in rapporto con la nostra finitudine. E con altri fantasmi che hanno nome Morte, Desiderio, Legge.) Se non alla donna, si piegano all´ascolto dei bambini. Prima le donne e i bambini - non è così? Non bisogna difendere i più deboli? le donne, che patiscono di più le ipocrite leggi della morale vittoriana, i bambini che soffrono di più in famiglia? Se la psicoanalisi degli inizi vuole parlare del sesso, è per sfondare il muro del silenzio che lo circonda: sotto l´effetto di illusioni emancipatorie, illuministiche, crede di poterci liberare dalla repressione.
E´ sotto gli occhi di tutti che non è stato così. Oggi le differenze chiedono diritti, non libertà. E l´istanza del potere e della padronanza diffondono in tutti il miraggio della soddisfazione a vantaggio del piacere conformista. Direbbe Freud: infinite sono le astuzie, incredibilmente convoluti i meandri dell´economia del piacere.
Io aggiungerei: nella spirale del piacere e del potere non c´è più chi si strugga per il primo. Anzi, sempre più gente li confonde. E visto che sono stata severa con questo libro, chiuderò con un´osservazione a suo favore: meditare sulla vita di eroine che si sono battute a ragione o a torto per liberare la verità del sesso fa bene alla salute mentale. Specie per chi non ha altri altari a cui pregare.
In più, queste donne manifestano un modo di relazione all´altro esemplare per attenzione, amicizia, ascolto. Sì, tutte le donne di Freud, avendo intrapreso la strada della psicoanalisi come professione e missione, nel pensiero e nell´atto testimoniano che si potrebbe arrivare a pensare al mondo come a una casa. E al pensiero medesimo come a una terapia contro lo sradicamento e la perdita di mondo. Che sia questo essere donne? Freudiane, o meno?
Repubblica 28.6.07
Oggi un convegno a Roma
I socialisti liberali in Europa
ROMA - "Socialismo liberale oggi in Italia ed in Europa" è il tema del convegno che si tiene oggi a Roma dalle 10 nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. Ad aprire i lavori sarà la relazione dello storico Massimo L. Salvadori dedicata a "Il socialismo liberale da Rosselli a Bobbio". Nel corso della giornata, sono previsti ancora gli interventi di Alessandro Roncaglia su "Il socialismo liberale in Paolo Sylos Labini" e di Pietro Rossi. Partecipano, tra gli altri, Giorgio Ruffolo, Giulietto Chiesa e Achille Occhetto.
Repubblica 28.6.07
Il maschilismo dei romani
di Eva Cantarella
Anticipiamo parte del contributo di Eva Cantarella sulla condizione femminile nell´antica Roma pubblicato su National Geographic in edicola da oggi
Nei lunghi secoli della storia di Roma, la condizione femminile cambiò profondamente. Nel periodo più antico della loro città, infatti, i romani riservarono alle donne un ruolo ben preciso: mogli e madri, riservate, sottomesse ai loro uomini (padre prima, marito poi), caste prima del matrimonio, rigorosamente fedeli se sposate; e soprattutto, sempre, silenziose. Come dimostra la storia di un´antica divinità dal nome molto significativo, Tacita Muta. Prima di assumere questo nome, leggiamo nei Fasti di Ovidio, Tacita era una ninfa di nome Lara (dal verbo greco laleo, parlare), che, purtroppo per lei, un giorno ebbe la pessima idea di svelare alla sorella Giuturna l´amore che Giove nutriva per lei, rendendo vani i tentativi di seduzione del dio. Per punirla, Giove le strappò la lingua, e partire da quel giorno Lara divenne Tacita, e fu onorata come dea del silenzio. Una storia dal valore pedagogico molto chiaro, quella di Lara-Tacita: se aveva fatto cattivo uso della parola non era stato per leggerezza individuale, era stato perché era una donna. Inevitabilmente, per una caratteristica e un difetto tipicamente femminili. Tacere, dunque, per evitare di parlare a sproposito, era un dovere fondamentale delle donne, al quale molti altri si affiancavano: non contrastare i desideri degli uomini, non immischiarsi nei loro affari, non mettere mai in discussione il loro comportamento, e ovviamente, lo abbiamo detto, mantenersi "pudiche", la parola che a Roma indicava le donne che rispettavano la regola della castità se nubili e della fedeltà se sposate.
Cosa accadeva alle donne che non rispettavano questi doveri? Per quanto riguardava la pudicizia delle donne sposate, la risposta viene da una legge, attribuita a Romolo, che stabilisce i poteri del "tribunale domestico". Il marito giudicava con i parenti in questi casi: se la moglie aveva commesso adulterio o se aveva bevuto vino. In ambedue i casi Romolo concesse di punirla con la morte. Non solo l´adultera poteva essere messa a morte, dunque, ma anche la donna che beveva vino. Inutile dire che i tentativi di comprendere le ragioni di quest´ultima regola sono stati molti (...). Ma la spiegazione più convincente della regola è quella che ne davano i romani stessi: bevendo, le donne potevano perdere il controllo, commettere adulterio, e più in generale comportarsi in modo disdicevole: «La donna che beve vino», scrive Valerio Massimo, «chiude le porta alla virtù, e la apre ai vizi». Comunque la si interpreti, la regola è evidente e indiscutibile espressione del desiderio di controllare la popolazione femminile, imponendo una riservatezza che, accanto alle altre virtù femminili, prevedeva anche il dovere primario del silenzio. Per i Romani, la parola era virtù e privilegio maschile.
Corriere della Sera 28.6.07
Tom Holland pone il conflitto greco-persiano all'origine di quello attuale. Un'analisi che fa discutere
Perché ci odiano
Il mito millenario e la «domanda di Erodoto»: da dove viene lo scontro di civiltà con l'Oriente
di Luciano Canfora
«Perché ci odiano?», la storia stessa è nata con questa domanda giacché fu nel conflitto fra Oriente e Occidente che il primo storico del mondo, nel lontano V secolo a.C., scoprì il tema dell'opera di tutta la sua vita. Si chiamava Erodoto.
La differenza tra Oriente e Occidente — scrive Tom Holland ad un certo punto della prefazione al suo Fuoco Persiano (Il Saggiatore, pagine 448, e 22) — è il «presupposto più duraturo della storia ». Che il pensiero di Holland sia attizzato dalla attuale, fittizia, contrapposizione tra Bush e Ahmadinejad è dimostrato dal fatto che la domanda attribuita all'attonito Bush dopo l'11 settembre 2001, «Perché ci odiano?», viene da Holland attribuita direttamente ad Erodoto: la brillantezza sfiora la disinvoltura. Infatti Erodoto non si esprimeva così, si poneva invece la domanda intorno all'origine del conflitto greco-persiano e inoltre prometteva un racconto che desse conto della grandezza sia degli uni che degli altri, tanto da essere definito — sei secoli dopo — «filobarbaro» da Plutarco in uno scritto che è soprattutto una esercitazione scolastica. Naturalmente il conflitto greco-persiano si presta a tali diagnosi sommarie ed inoltre è materia che, nonostante il moltissimo che se n'è scritto (penso alla fondamentale Bataille de Salamine edita a Parigi dal greco Rados nel 1915), continua ad appassionare e a suscitare nuove ricostruzioni talvolta molto ben fatte, come ad esempio La forza e l'astuzia di Barry Strauss (Laterza 2004).
Holland ha il pregio di saper narrare, e quindi — trovandosi necessariamente debitore delle fonti antiche — sa amabilmente rielaborarle e vivacizzarle. Anche facendo intervenire la fantasia: come quando immagina «il calpestio dei piedi dei soldati che ripiegano» (p. 286) o la non attestata «corsa» di Ipparco attraverso una piazza di Atene nel giorno dell'attentato (p. 142). Lui stesso ci scherza su, quando autoironicamente descrive il ruolo delle sue note a piè di pagina, preannunziate — scrive — da «un numero nel testo aleggiante come una mosca su un mucchio di letame» (p. 22).
Ciò che però merita, soprattutto, attenzione non è tanto la brillantezza della ricostruzione quanto la sua ferrea unilinearità ancorata all'antagonismo Oriente/Occidente visto appunto come «presupposto duraturo della storia» e incarnato, per così dire, dallo scontro armato tra Greci e Persiani nei primi decenni del V secolo a.C. Lo schema è tenuto fermo da Holland fin nel «commiato » del volume culminante nella vittoria di Alessandro sui Persiani. Molte incrinature si potrebbero in verità infliggere a questo schema. Per esempio, richiamarsi al giudizio di Tucidide secondo cui le guerre persiane ebbero assai minore importanza rispetto al conflitto di potenza tra gli stessi Greci, la cosiddetta «guerra del Peloponneso ». Oppure ricordare che per gran tempo la storia delle città greche aveva avuto nel re di Persia e nei suoi satrapi i principali registi: ben prima di Beloch, lo pensava già Demostene, ma di sicuro, ancor prima, Ippia e lo stesso Temistocle. E scendendo nel tempo si potrebbe osservare che, a lungo, il grande antagonista dell'impero romano (cioè dell'«Occidente» per eccellenza) furono i Germani a Nord ben più che i Parti ad Est; e che comunque l'impero romano cosiddetto «d'Oriente» o «bizantino», pur essendo innegabilmente e legittimamente l'erede di Roma (la «Seconda Roma»), fu via via trattato dagli Occidentali come un nemico se non addirittura come la quintessenza dell'Oriente. Insomma aveva ragione Gibbon quando scriveva (ma Holland se ne libera senza discuterlo) che «la differenza tra Est e Ovest è arbitraria e si sposta intorno al globo».
In un libro giovanile, pieno di intelligenza, Santo Mazzarino parlò, per l'età arcaica, di «due Orienti»: quello del mondo microasiatico sfociante nella Ionia e quello assiro- babilonese (poi persiano) che «feconda la grecità» ( Tra Oriente e Occidente, Bollati Boringhieri, p. 24). E in un celebre saggio di molti anni più tardi ( Persian Empire and Greek Freedom, 1979) Momigliano osservò, tra l'altro, che «conosciamo circa 300 nomi di Greci che operarono al servizio dei Persiani nei circa due secoli prima di Alessandro»: medici, artigiani, mercenari etc. Per non parlare dei moltissimi che si schierarono con Serse già nel 480-479, o della opzione filopersiana dello stesso oracolo di Delfi.
Eppure non si trattava solo di propaganda. Cosa c'era dunque di «incompatibile» tra Greci e Persiani, nonostante tutti gli intrecci, i compromessi, le temporanee dipendenze? Momigliano rispondeva all'ineludibile quesito additando la scelta, greca, di porre «le leggi» al di sopra del «potere» dispotico; il quale può essere illuminato ma anche non esserlo. Focilide proclamava la superiorità di una «città ordinata» persino rispetto alla splendida Ninive.
Ma è il corto circuito tra l'antico e l'odierno conflitto che non funziona. L'«Oriente» contro cui oggi reputiamo (o meglio alcuni reputano) di essere in guerra non è che una creazione retorica. È Oriente la Russia alle prese coi Ceceni? O l'India alle prese con il rissoso vicino pakistano?
Muro contro muro, da 2500 anni
Perché ci odiano? Nei giorni e nelle settimane che seguirono l'11 settembre, il presidente Bush non era l'unico a porsi quella domanda assillante. Sui giornali innumerevoli esperti tentavano di spiegare il rancore dei musulmani per l'Occidente, facendo risalire le sue origini alle bizzarrie della più recente politica estera americana oppure, risalendo ancora più indietro, alla spartizione del Medio Oriente operata dalle potenze coloniali europee o addirittura — seguendo l'analisi di Bin Laden a ritroso, fino al suo punto di partenza — alle crociate stesse. Nell'idea che la prima grande crisi del XXI secolo potesse essere emersa da un vortice di odi antichi e confusi c'era un'evidente ironia: la globalizzazione avrebbe dovuto sancire la fine della storia e invece sembrava destare dal loro riposo ancestrale un gran numero di fantasmi sgraditi. Per decenni l'Oriente a cui l'Occidente si è contrapposto era comunista; oggi, come da sempre prima della rivoluzione russa, è islamico. La guerra in Iraq; la crescita in tutta Europa di sentimenti di intolleranza verso gli immigrati, soprattutto se musulmani; la questione dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea; tutto questo, combinato con gli attacchi dell'11 settembre, ha alimentato un'angosciosa consapevolezza della spaccatura che divide l'Occidente cristiano dall'Oriente islamico. Che le civiltà siano condannate a nuovi scontri, come hanno variamente sostenuto i terroristi di al-Qaeda e gli studiosi di Harvard, rimane tuttora una tesi controversa. Ma è indiscutibile che le diverse culture, almeno in Europa e nel mondo musulmano, attualmente sono obbligate a esaminare con attenzione le fondamenta stesse delle loro identità. «La differenza fra Est e Ovest», pensava Edward Gibbon, «è arbitraria e si sposta intorno al globo». Tuttavia, il fatto che esista... l'Oriente è l'Oriente, l'Occidente è l'Occidente — è senza dubbio il presupposto più duraturo della storia. Molto più antico delle crociate, dell'Islam o del cristianesimo, la sua ascendenza risale quasi a 2500 anni fa.
Il Giornale 28.6.07
E la sinistra radicale si smarca: serve una forza vicina alla gente
Si affievolisce lungo la strada, la novella veltroniana. Dal salottino buono democratico ai rudi cantieri della sinistra, la voce si perde nel vuoto.
Tanti auguri, sei nu bravo guaglione, amici come prima. O «ex », come nel caso di Cesare Salvi. Soddisfatto del discorso di Walter: «Veltroni ha rafforzato il nostro convincimento, non soltanto di non entrare nel Partito democratico, ma anche di dare vita a una grande forza della sinistra in Italia». Un discorso «ideologicamente vecchio» lo bolla il capogruppo della Sinistra democratica al Senato. E non tanto perché siano cambiate anche alcuni punti di riferimento (De Gasperi), quanto perché Veltroni pare richiamarsi al «blairismo proprio mentre Blair esce di scena». Il ragionamento di Salvi condensa la sensazione agro-dolce connessa alle relazioni tra il nuovo candidato leader del Pd e la Sinistra alternativa. «La capacità della politica è di dare risposta ai problemi contemporanei, e non è con queste generiche forme che si dà risposta: si conferma che il Pd non sarà nel socialismo europeo, c’è una proposta di riforma istituzionale in senso presidenzialista anch’essa vecchia, mentre oggi la crisi della politica è crisi di partecipazione e consenso dei cittadini, non crisi di decisionismo».
Insomma, «noi siamo un’altra cosa». È sulla facile differenziazione dal veltronismo anche ogni commento che arriva da Rifondazione, nonostante (forse proprio per) la benevolente accondiscendenza dichiarata da Bertinotti nei confronti del giovane Walter, così incline a occuparsi degli ultimi della terra. Già, ma in che modo? Con belle frasi e scarso ancoraggio alla scomoda realtà. «A questo Paese serve una forza politica che stia sulla dimensione dei bisogni delle persone», per dirla con il capogruppo dei deputati prc, Gennaro Migliore. «È un leader autorevole e significativo - si sforza Franco Giordano -, di un partito che ha il profilo di una forza moderata». Le differenze «ci sono e rimangono», constata Giordano. E invita Veltroni, casomai volesse conquistarsi la leadership dell’Unione, nelle secche di un «confronto con le culture e i programmi delle sinistre all’interno di un grande percorso di partecipazione democratica».
Non spaventa l’alleato Walter. «Se ci spaventassero gli alleati saremmo davvero in cattive acque», scherza Migliore. Ma se il Pd «è per una società interclassista», Prc vuole lavorare a «dare una rappresentanza ai giovani precari, ai lavoratori, ai pensionati». Stesse note suona il capogruppo dei deputati pdci, Pino Sgobio, che rimprovera a Veltroni «l’errore di presentare le pensioni come uno scontro tra generazioni» e l’aver dimenticato che «la priorità è il lavoro di qualità». Auguri arrivano dal capogruppo dei Verdi alla Camera, Angelo Bonelli, che con gusto vagamente ironico manifesta soddisfazione per l’inserimento dell’«ambiente e del clima nelle previsioni programmatiche del Pd». Peccato però che «sino ad oggi il Pd ha proposto carbone, il ritorno al nucleare, un maggiore consumo del suolo e della aree agricole». Pronti a confrontarsi nei fatti con Veltroni, conferma Pecoraro Scanio, a patto che sappia «far valere nel Pd ciò che sino ad oggi non si è verificato, perché un Rubbia o un Gore che dicono no al carbone sono lontani mille miglia dall’attuale gruppo dirigente del Pd».
Mille miglia è la lontananza, per ora, dal cantiere socialista. Il segretario Enrico Boselli apprezza che Veltroni «abbia cercato di dare un’anima a un partito che non ce l’ha». Nonostante l’appello veltroniano, i socialisti ritengono che «un conto sia il leader, un altro il partito che sta nascendo, con forti componenti integraliste e clericali». Bravo il primattore, scadente commedia e casting: «Buona recita su uno spartito scontato», constata da spettatore Lanfranco Turci. Oppure, come piace immaginare a Roberto Villetti, Veltroni è piuttosto «acqua gettata sul terreno arido di Quercia e Margherita». Acqua fresca per vegetali assetati. Ma pur sempre, irrimediabilmente, vegetali.
Liberazione 28.6.07
L'americano di Roma che vuole cambiare l'Italia
di Stefano Bocconetti
, Torino. Stati Uniti. Se i simboli hanno un senso, Walter Veltroni, nel discorso in cui ha accettato di fare il leader del piddì, in un'ora e mezza ha fatto un lunghissimo percorso. Lineare, diretto come forse non gli era riuscito neanche all'ultimo congresso dei diesse. Un'ora e mezza di parole, slogan, ragionamenti e immagini colorate che portano la sua nuova formazione esattamente al di là dell'Oceano. Stavolta senza possibilità di equivoci. Perché alla fine, quando la sala - ben selezionata nonostante gli annunci che la volevano aperta "solo" al popolo dei democratici - era già pronta agli applausi finali, il sindaco di Roma ha detto chiaro e tondo che il suo modello, modello sociale, sono gli States. Userà queste parole: da noi, in Italia, il fatto che «il figlio di un operaio debba continuare a fare l'operaio» mentre «il figlio del dottore avrà tutte le porte aperte» dipende da una nuova categoria della sociologia. Inventata per l'occasione: "l'ereditarismo". Altra cosa è invece l'America. Dove - dice - tutti hanno le chances per provare a salire. Sù, in alto. Magari molti cadono, ma qui siamo pur sempre in Europa e allora, a differenza di quanto avviene in America, si può pensare che invece di finire in una roulotte possa intervenire ciò che resta del welfare. Ma sono dettagli. L'unica cosa che conta è che lì, negli States, «ci si può provare». A disegnarsi un futuro se non migliore, almeno più ricco. Economicamente.
America, allora, quest'America. Sarà la cifra, l'identità del nuovo partito. Veltroni comincia a disegnarla proprio qui, a Torino. Puntuale, puntualissimo il sindaco si presenta nella ex-sala delle presse, ridisegnata da Renzo Piano, alle cinque del pomeriggio. Non è vero come avevano sostenuto gli uomini del suo staff che non ci sarebbero state sedie a disposizione degli invitati. A loro, ai big erano riservate le prime sei fila. Così c'è qualche malumore, soprattutto fra chi aveva creduto a quello che aveva letto sui giornali. E magari sognava di occupare un posto e lasciare in piedi i dirigenti della Fiat o l'amministratore delegato di BancaIntesa. Un po' di tensione ma bastano le parole di Veltroni, quando dice che comunque dopo il discorso andrà a salutare di persona anche chi ha dovuto seguire la manifestazione nel maxischermo allestito in un'altra sala, per riportare la calma.
E si comincia. Metà sala gialla - si chiama così ora questo pezzo della vecchia fabbrica - è piena soprattutto di giornalisti e amici di Veltroni, il pubblico è piuttosto avanti con gli anni. Ma che discorso sarà quello del neocandidato (un eufemismo perché in mancanza di rivali è già neosegretario) del piddì? Difficile da sintetizzare, difficile definirlo con un solo aggettivo. C'è molta America, s'è detto. Ed esattamente come nelle parole di alcuni dei leader democratici di oltre Oceano i "capitoli" del suo discorso contengono parole care alla sinistra.
Dentro, però, dentro quei paragrafi ci sono idee, progetti, proposte politiche moderate. C'è una filosofia che tutto si può definire meno che di sinistra.
Così è sulla precarietà. Veltroni dice che la lotta alla precarietà deve diventare l'essenza del nuovo partito democratico. Precarietà che non rende solo difficile il lavoro ma "invade" tutte le sfere della vita. Arriva anche nei rapporti personali. Sembra l'inizio di una sfida a sinistra, verso una sinistra che di questi temi ha fatto una bandiera. Ma non sarà così. Perché subito dopo Veltroni spiega che le imprese hanno il diritto ad assumere pagando meno un dipendente al primo impiego. Semmai deve essere poi lo Stato a non lasciare "soli quei giovani". Come fare? Con un nuovo patto fra generazioni. Slogan altisonante ma che si traduce in un semplice invito alla moderazione rivolto al sindacato. Che deve smetterla di difendere solo gli occupati stabili e i pensionati, deve smetterla di concentrarsi solo sull'abolizione dello scalone. Ma deve pensare a come spostare risorse dal sistema pensionistico, dal welfare al sostegno dei giovani.
E visto che si parla di risorse, qui Veltroni piazza uno dei suoi affondi. Di quelli che faranno più discutere. Sostenendo che è ora di mettere da parte una vecchia idea della sinistra che chiede più tasse per spendere di più. In Stato sociale. Ovviamente lui accetta l'idea che una riduzione potrà avvenire solo quando sarà colpita completamente l'evasione. "Pagare meno, pagare tutti", dice. Ma aggiunge: non è detto che solo quando si realizzi la seconda condizione, si debba realizzare anche la prima. Insomma, bisogna trovare i sistemi per cui la riduzione delle tasse o la semplificazione del sistema fiscale possa partire da subito. Soprattutto per le piccole e medie imprese che sono il "cuore di questo paese". C'è anche un applauso a questo passaggio. Piccolo ma significativo.
Titoli dei capitoli di sinistra, si diceva. Come sulla questione ambientale. Qui Veltroni fa sfoggio di aver letto le risoluzioni dei social forum. E dice che l'ambientalismo non può essere un argomento che si aggiunge agli altri. Deve essere il cuore, "il perno" di qualsiasi politica. Anche qui: sembra che parta una sfida diretta ai movimenti, alle comunità che su questo tema hanno elaborato e costruito vertenze. Ma è l'esatto contrario. Perché da quel presupposto Veltroni parte proprio per colpire i "movimenti". E dice che l'ambientalismo moderno oggi si traduce col sì all'Alta Velocità, il sì ai rigassificatori.
Stesso schema, sulla scuola, l'istruzione. Chiede soldi, spese, risorse da destinare alla ricerca. Salvo poi aggiungere che vorrebbe un sistema più legato alla formazione professionale. Alle esigenze delle imprese.
Dove invece quel modello - parole care alla sinistra, contenuti di destra -quel modello, si diceva salta è sulla questione immigrazione. Che Veltroni tiene unita al tema della sicurezza. E qui ci sono solo i luoghi comuni che si leggono ogni giorno sui quotidiani. Certo, il sindaco che va in Africa ad inaugurare scuole non può esagerare. E infatti invoca inclusione, tolleranza. Come quella che invocavano i nostri nonni quando arrivavano da migranti in America (sempre lì si finisce). Però poi, sillabando le parole, chiede "più polizia nelle strade, nei quartieri". Chiede, urla, "la giusta punizione per chi attenta al diritto alla sicurezza dei nostri concittadini". Qualcuno lo applaude anche a questo passaggio.
Questi, questi quattro punto programmatici, sono la piattaforma del suo piddì. Per il resto è il Veltroni di sempre. Quello che usa le parole giuste al momento giusto. E così dopo un'ora abbondante di dettagli sulle singole proposte, ecco i voli pindarici. Di un partito che non deve essere la semplice sommatoria delle tradizioni socialista e cattolica sociale ma deve - naturalmente - essere "una casa aperta". Alla società civile. Un posto dove la gente, le persone si rivolgano per risolvere i propri problemi. Il Veltroni di sempre. Che cita De Gasperi, Olof Palme e Vittorio Foa. Più la lettera di una ragazza di quindici anni, che non c'è più, stroncata da un male incurabile. Pacato, equilibrato. Al punto che dice di sì alle preoccupazioni espresse da Pezzotta al family day ma dice anche di sì - e lo dice molto chiaramente - all'approvazione della legge sui Dico. "Perché la cosa più grave sarebbe imporre uno strano bipolarismo: da una parte l'integralismo dall'altro un anacronistico laicismo". La scelta giusta - anche qui: naturalmente - è al centro esatto delle due tesi.
L'unico argomento dove il sindaco concede poco alla mediazione è sulla legge elettorale. Suo vecchio pallino. La vuole bipolare, perché i guai dell'Italia sono in un eccesso di frantumazione, bipolarissima. Con qualche riconoscimento al diritto alla rappresentanza ma soprattutto con una legge capace di dare gli strumenti al governo per governare.
Veltroni di sempre, si diceva. Con in più, ed è forse uno degli elementi di novità di ieri, col fatto che stavolta Veltroni sembra ben cosciente del suo ruolo. Dice che da quando è "intervenuta questa novità", cioè la sua candidatura, il piddì è schizzato nei sondaggi, l'Unione torna in testa. Piddì e Unione: li cita in quest'ordine. Nel primo caso la sua leadership è certificata dall'entusiasmo del Lingotto. Nel secondo caso, la sua direzione sarà tutta da conquistare. Ma nessuno ci fa caso, qui a Torino. Finisce così. Come annunciato, con le musiche di Edward Elgar, il musicista tedesco che piaceva a Stanley Kubrick. Ma non sarà l'unico elemento della colonna sonora. C'è spazio anche per i Procol Harum, un po' di anni '60, figurine Panini e tv in bianco e nero servono sempre. E per i Counting Crows. Folk rock americano. Semplice, a tratti banale. L'America di largo consumo, insomma.
Liberazione 28.6.07
Suore e leader, sindaci e manager: la doppia platea abbraccia Walter
Politici e dirigenti locali sono in Sala Gialla, il popolo nello spazio attiguo con maxischermo
Dei membri dell'Unione presenti solo Fassino e il probabile futuro vice-segretario Franceschini
di Angela Mauro
È seduta in prima fila già dalle quattro del pomeriggio, quando fuori dal Lingotto la "gente normale" fa la fila, mentre politici e giornalisti entrano dall'ingresso riservato. Impossibile non notarla: un capo coperto da un velo, alle kermesse di politica, fa scena, di sicuro. Non è islamica, tanto meno una sposa, ma una religiosa e nemmeno di poco conto. Lei è suor Giuliana Galli, coordinatrice del volontariato al Cottolengo, esempio in carne e ossa della "sintesi" veltroniana tra l'integralismo religioso e il laicismo esasperato. Spiega di essere stata invitata dal sindaco Sergio Chiamparino e non nasconde tutta la sua curiosità per questo ‘nuovo' leader venuto da Roma. "Non è curiosità, è empatia", corregge. "Sono qui per ascoltare, voglio sapere cosa vuol fare della ‘polis' italiana che è fatta di giovani, di anziani, di deboli…". Sì, ma Veltroni le piace? "Mi piace, sento in lui una serie di interessi… come dire? Umani. L'ho visto in azione negli slums di Nairobi e non ci sto a trattare da perdente chi accetta di muoversi in ambienti non suoi. E poi l'ho visto a Narni, al festival del cinema: un politico che si occupa di cinema!". Ma era ministro per i Beni Culturali, le si fa notare: sorella, anche Rutelli lo è adesso… Suor Giuliana non si lascia ingannare, nemmeno sul Partito Democratico che liquida con quattro speranze, anzi virtù: "Prudenza, giustizia, forza, temperanza". E via, torna alle prime file che nel frattempo si sono riempite di politici e personaggi noti. Oltre al sindaco di Torino, Chiamparino, c'è Marta Vincenzi, neo eletta a Genova, c'è il presidente della provincia di Milano Filippo Penati, c'è Gibelli ma manca Cofferati, e poi è presente il presidente del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo Enrico Salza, il parlamentare dell'Ulivo Franco De Benedetti, e due big (solo loro) del Partito Democratico: Piero Fassino (che ha già avuto modo di parlottare con Walter alla partenza dalla capitale in aeroporto a Fiumicino) e Dario Franceschini (indicato come il futuro vice di Veltroni alla guida del Pd). E poi una marea di giornalisti, cameramen e fotografi, quelli locali e quelli arrivati dalla capitale con il sindaco Walter: si aspettavano un ambiente senza posti riservati, popolare, senza inviti ai vip di riguardo. Invece no: le poltronissime sono prenotate e transennate, le poltrone non lo sono, ma sono poche (in totale la Sala Gialla del Lingotto fa circa 600 posti) e accolgono solo una piccola parte della gente arrivata per assistere all'incoronazione del candidato "principe" nella competizione per la leadership del Pd e forse anche di un futuro governo di centrosinistra. Come nel teatro elisabettiano, il vero popolo, i "groundlings" di Torino, stanno in piedi, con una differenza però rispetto ai tempi di Shakespeare: non sono vicini al palcoscenico, ma in un immenso spazio attiguo, che riempiono solo in piccola parte, davanti ad un maxischermo.
In Sala Gialla, l'atmosfera (pur conviviale, di quelle da feste tra amici, ambiente alla fine dei conti composto da quadri locali) è volutamente teatrale. Luci soffuse che si abbassano quando il leader prende la parola alle 17 in punto (come da programma, impeccabile, spacca il minuto). Musica di sottofondo all'inizio (tra cover dei Beatles e qualcosa di più moderno) che va in crescendo man mano che si avvicinano le 17. Luci verdi sul palco quando Walter comincia. Verdi come la moquette e come i prati delle campagne italiane immortalati nei cinque maxischermi fino ad un secondo prima della frase d'esordio: "Fare un'Italia nuova". A quel punto, sul maxischermo centrale, via alle immagini che da Torino, una dopo l'altra, mostrano una "sintesi" dei paesaggi, dei monumenti, dei volti italiani "secondo Veltroni": un gruppo di amici tutto sorriso e benessere, l'imbarazzante primo piano di due fidanzatini di un ‘paese normale', lo sguardo complice di una coppia di anziani, fino al fermo-immagine sugli occhi blu di un bambino. Il leader, riprodotto sugli schermi laterali, parla a braccio per un'ora e mezza, mai un'occhiata al leggìo, due mini-microfoni sistemati sulla giacca, uno sguardo a sinistra, uno a destra, uno al centro, per incrociare gli occhi e l'attenzione di tutti (proprio tutti: sul palco c'è anche chi pensa a ‘tradurre' il discorso per i non udenti). Nessuna sbavatura, nessun tono da comizio. E il dubbio emerge: avrà un gobbo davanti a sé come si usa a teatro e in tv? Ci si fa strada per guardare: no, in linea d'aria c'è Fassino.
La platea lo ascolta in un silenzio che si interrompe solo per brevi applausi: evidentemente di rito quando il leader nomina e ringrazia Prodi e Rutelli, più calorosi per Fassino (accolto con entusiasmo anche all'arrivo nella sua Torino), spontanei e sentiti quando il tema diventa la sicurezza, il referendum sulla legge elettorale, la riduzione dei costi della politica e del numero dei parlamentari, il "basta con la politica dei veleni", ma anche il "sì alla Tav". E' prevalentemente ascolto, però. La vera acclamazione avviene nella sala attigua perché il vero popolo sta lì e Walter lo sa. Tant'è vero che, alla fine del discorso, sulle note di una versione aggiornata della ormai 40enne "A whiter shade of pale", non si esime dall'affrontare il breve ma faticoso tragitto (spaventosa ressa di giornalisti e bodyguard) per andare a salutarli. E' qui che c'è il calore. I ‘groundlings' urlano: "Walter, Walter!". Lui riesce a trovare un podio improvvisato e diventa tribuno solo per loro: "Il Partito Democratico, una forza, una necessità…". Sono ‘groundlings' anche i giovani del gruppo ‘Italia 2.0', rete chiamata così perché "come avvenuto per il web, vogliamo una nuova versione dell'Italia", spiega uno di loro, Andrea Appiano, giovane sindaco della vicina Bruino. Si erano sistemati fuori dalla Sala Gialla con un banchetto: volantini e relativo cd rom sistemati sul collo di bottigliette di acqua minerale, richiamo ad un noto brano dei Police. E infatti: "Vogliamo consegnare il nostro ‘message in a bottle' a Walter: non vogliamo subire il Partito Democratico", dice ancora Andrea, sicuro di incrociare la sensibilità politica (e quella musicale) del sindaco-leader. Chissà se ci sono riusciti, magari ci ha pensato lui ad intercettarli.
Liberazione 28.6.07
L'Evento, l'ultimo colpo grosso firmato Walterino
Ecco a voi Lui, la "risorsa". Biografia di un buonista d'acciaio
di Maria R. Calderoni
Non è certo La Madonna Apparsa Ai Pastorelli, ma il colpo grosso gli è riuscito ancora una volta: fare di se stesso un Evento, arte in cui - tutti glielo riconoscono - è maestro. Perchè, se la sua discesa in campo era, se non annunciata, però sussurrata e chiacchierata da tempo nel gossip giornalistico, nessuno si aspettava che avvenisse così fragorosamente, se due-tre pagine sul Corriere della Sera vi sembran poche. Dicono che a Bruxelles, dove era in trasferta, Prodi sia sobbalzato (e anche un po' impallidito), sorbole, mica se l'aspettava, così in fretta, così grosso. Walter Veltroni.
Walterino, come era chiamato a tempi della Fgci romana. Ancora una volta, come nel '96, "avallato" in pubblico da D'Alema: ecco a voi Veltroni la "risorsa". Una «brava persona» che «non ha mai vestito da comunista», ma che, da amante del cinema qual è - ha commentato a caldo Marcello Dell'Utri, «conosce bene gli effetti speciali». Ecco a voi Veltroni la "magia". A guardar bene il clamore mediatico intorno a lui lievita come panna ben frullata, la celebre galassia Veltroni. Le pagine sono piene più che delle sue gesta, dei suoi amici, sostenitori, laudatori e fan, tutti pazzi per lui. Da Sabrina Ferilli a Woody Allen, da Scola a Fuksass, da Piovani a Lando Buzzanca, e ancora ancora. Una claque formidabile, per Carlo De Benedetti, tessera Pd numero 1, «un leader vero»; per Fausto Bertinotti «un nome fortemente innovativo». E anche lo chiamano astro, icona, salvatore, spiazzante, forte, anche «circondato da un alone di popolarità e di attesa». Tutto un osanna scoppiato all'improvviso, ma con raffinata regia occulta, al momento giusto, proprio mentre il già celebrato "fattore c" sembra avere definitivamente abbandonato «il povero Prodi». Walterino. OrzoBimbo, per Cossiga. Cortese Rospetto, per la Rossanda ai tempi del dopo Dini. Anche Buonista dai denti d'acciaio, come qualcuno lo ha definito ad Orvieto, in un convegno della Sinistra alternativa.
Classe 1955, famiglia borghese intellettuale, Walter Veltroni ha raccontato in uno dei suoi libri che da ragazzo sognava di fare il regista, di dedicarsi al cinema. Ma poi sulla sua strada ha incontrato il Pci e lì è rimasto. Per un bel po', diciamo per oltre vent'anni, fino alla Svolta; comunque abbastanza per farci un bel pezzo della sua gran carriera. Giovanissimo è nella segreteria della Fgci romana, giovanissimo è eletto consigliere comunale, a 32 anni è responsabile nazionale della Stampa e Propaganda. Nel "Partito più Partito che c'è" trova anche la donna della sua vita: Flavia, generone comunista, con la quale è sposato da oltre vent'anni e ha avuto due figlie. Convinto adepto di Occhetto e assertore entusiasta della Svolta, nel Pds percorre un altro bel pezzo del suo cursus, costruendo con implacabile lucidità e accortezza la costruzione del proprio personaggio, l'immagine di sè. Riuscendoci alla grande.
Sarà un memorabile direttore dell'organo del Partito, l'Unità (per via delle figurine Panini, i film e i libri venduti col giornale), poi vicepresidente del Consiglio, poi segretario del partito, poi avrà lo scranno di sindaco. Sempre utilizzando il famoso "metodo veltroniano", quello che descrive bene Andrea Romano ("Compagni di scuola" Mondadori). Veltroni,«un politico new age, capace di elaborare il comunismo in un battito di ciglia, senza abiure e sofferenza, facendosi placidamente trasportare dalla corrente di un senso comune dove si può dre tutto e il contrario di tutto». Per esempio «affermare serenamente di non essere mai stati comunisti, secondo la sua celebre battuta, in quanto si militava in un Pci privo di comunismo». Sempre sulla stessa linea, ecco la ingegnosa invenzione di Berlinguer-Kennedy, vale a dire di «un leader insieme comunista e anticomunista. Capo di un partito comunista - scrive Walterino in un' intervista del 1978 - dove poteva benissimo sentirsi a casa chi comunista non era» (come lui, appunto). Del resto - è sempre la stessa intervista - «nella mia formazione, l'Urss era nemica e gli Stati Uniti erano la cultura di riferimento». E' Veltroni fin da piccolo. E' appena approdato in un ruolo di direzione nella Fgci romana, ma già spicca nell'esercizio di quella manipolazione delle immagini che diventerà il suo asso vincente. «Come nel 1973, quando - racconta sempre Andrea Romano - si cimenta forse per la prima volta da un palco di partito con il tema delle politiche radiotelevisive, mescolando acrobaticamente Lenin e Lewis Carroll, le Pantere Nere e Alice».
Veltroni per sempre. Mai senza successo. In un articolo del luglio 1994, Francesco Merlo descrive quello che secondo lui è «il topos della sua vita: sono gli altri ch giocano, ma alla fine è lui, Walter, che ha segnato tutti i gol». Grande inventore di metafore, grande cacciatore di consenso via comunicazione, con D'Alema e Fassino ha già l'imprinting degli "splendidi quarantenni" che, dopo il crollo del Muro si troveranno in mano tutto il potere del Partito (e il segretario di transizione, l'intellettuale gentiluomo Alessandro Natta, verrà sbrigativamente e rudemente messo fuori, da quel fortissimo cast di giovani, Occhetto in testa. Quando a 32 anni, Walterino viene nominato alla guida della commissione Stampa e Propaganda di Botteghe Oscure, è già un personaggio pubblico estremamente popolare: dentro, ma sopratutto fuori dal partito. Mica per niente due anni dopo, allorché, per la prima volta il comitato centrale decide di votare direzione e segreteria a scrutinio segreto, sorpresa: Walterino ottiene un incredibile successo: 249 voti su 269 per la direzione e 256 per la segreteria. «I trentenni del 1986 avevano sconfitto i trentenni del 1956». E, «tra i maggiorenti della nuova leva, Petruccioli, Fassino, Livia Turco, D'Alema, Mussi», Veltroni ha il suo posto, straordinariamente a suo agio in quell'era di «parole al quadrato» che si apre nel partito, tramortito dall'angoscia e dal trauma dell'89. Tanto a suo agio, che riesce ad attraversare la tempesta in un soffio, senza uno strappo. E' solo uno "attrezzato" come lui, che può uscire «con la leggerezza di un ballerino dalla serie di tre sconfitte successive collezionate dai Democratici di sinistra durante la sua segreteria: le elezioni politiche del 1999, le regionali del 2000 e le politiche del 2001». Chiunque ne sarebbe stato schiantato, non lui.
Veltroni dei miracoli. Veltroni la risorsa.
Liberazione 28.6.07
Intervista al responsabile Giustizia Prc che ha guidato la commissione di riforma del codice penale:
«La lunghezza dei processi? Dipende esclusivamente da una macchina che non funziona»
Pisapia: «Abolire l'ergastolo non significa aiutare i boss»
D.V.
«Non è ammissibile attendere non meno di otto mesi solo per passare gli atti dall'aula di primo grado a quella dell'appello». Reduce dal titanico lavoro di riforma del codice penale - abolizione dell'ergastolo, introduzione di nuovi sistemi diretti ad assicurare la certezza e l'effettività delle sanzioni, ampia depenalizzazione, forti limitazioni alla discrezionalità dei giudici, riduzione dei tempi dei giudizi - Giuliano Pisapia interviene sulla lunghezza dei processi che si celebrano nelle aule di giustizia italiane. Un'idea chiara la sua: la mancanza della «ragionevole durata del processo» pone una questione di rispetto dei diritti costituzionali e da armi a chi brandisce e invoca meno garanzie per l'imputato.
Troppo garantismo allunga i processi nelle aule di giustizia?
L'indagine presentata dall'Eurispes è chiarissima. La lunghezza dai processi non deriva da cavilli che non esistono, nè dal sacrosanto rispetto delle garanzie, ma solo ed esclusivamente da una macchina che non funziona e su cui si dovrebbe incentrare l'interesse del governo. Basti considerare che bisogna attendere almeno otto mesi per far passare gli atti dell'aula processo di primo grado all'aula del processo di appello. Inammissibile in uno stato di diritto. Senza contare che tutto questo alimenta i pretesti usati in modo strumentale per attaccare le garanzie degli imputati.
La riforma del codice penale potrebbe aiutare a snellire?
Io credo che depenalizzare alcuni reati oppure affidarsi ad altri istituti quali la "messa in prova", che permette di verificare senza passare per i tre gradi di giudizio ma attraverso strumenti che possono accertare la non reiterazione del reato, siano strumenti utili. Senza contare che nella gran parte dei casi passano i tre gradi di giustizia e si arriva ad una sentenza assolutoria, oppure, nel migliore dei casi, ad una pena che in ogni caso non viene scontata perchè ritenuta inutile. Un altro strumento potrebbe essere dato dal principio dell'irrilevanza del fatto, ovvero quando il comportamento è occasionale e permette di adottare una formula che in altri ordinamenti ha funzionato. Ovviamente se poi il soggetto dovesse reiterare il reato, in quel caso la punizione sarebbe tradizionale. Poi bisogna puntare alla pena equa, una pena che può "soddisfare" anche l'imputato che in questo modo evita di impugnare la condanna per puntare alla prescrizione, cosa che accade nella gran parte delle impugnazioni. Insomma, possiamo immaginare tre punti fondamentali: rilevanza del fatto, messa in prova per i reati non gravi, pene non severe ma eque e non per forza di cosa detentive.
Nella sua riforma del codice penale si parla d abolizione dell'istituto dell'ergastolo. Nel mondo dell'antimafia c'è una certa diffusa preoccupazione...
Purtroppo in un progetto di codice composto da 68 articoli, si è preso un singolo comma di un articolo. Non si è tenuto conto del resto insomma. Vorrei specificare che quel comma è supportato per esempio dalla confisca dei beni mafiosi che se approvata sarebbe ci porrebbe all'avanguardia rispetto a tutti gli stati moderni. Vorrei inoltre ricordare che l'ergastolo esiste da sempre e la mafia non è stata debellata. Tutti concordano sul fatto che si deve incidere sul problema di beni della criminalità organizzata. Se ci soffermiamo su mezzo articolo non si capisce l'impostazione generale e la filosofia dell'intero progetto di riforma. Detto questo è evidente che la mia è un proposta tecnico-giuridica su cui dovrà esprimersi il Parlamento. A questo punto mi auguro che questo non divenga il pretesto per affossare tutta l'ipotesi di riforma. Vorrei infine sottolineare che l'altro giorno, a Siracusa, si sono riuniti molti professori, molti giuristi che hanno trovato utili gli strumenti offerti dal nuovo codice per la lotta alla mafia.
il manifesto 28.6.07
L'America fatta in casa
di Gabriele Polo
La «casa per l'Italia nuova» ieri proposta da Walter Veltroni trova i suoi natali in un «casa vuota»: il Lingotto di Torino, già luogo del conflitto di classe e dell'identità operaia, ora centro commercial-culturale che diffonde pillole di sapere in forma di mercato. La scelta del luogo non è stata casuale: non tanto il ritorno nella sede del congresso diessino dell'I care veltroniano, ma soprattutto il contrappasso tra due mondi, dal '900 delle grandi contrapposizioni che nutrivano la politica e cambiavano - nel bene o nel male - il mondo, al nuovo secolo dell'amministrazione più o meno saggia, più o meno onesta, dell'esistente; dal protagonsimo delle aggregazioni di massa al governo di leadership sempre più personalizzate.
Il tono è stato in sintonia con il luogo: non poteva ispirare sogni, semmai il pragmatismo di un sindaco che si è già fatto premier, incoronato dal collasso della rappresentanza che trasforma la democrazia in urgente decisionismo. Tono un po' inedito per chi banalizza il sindaco di Roma nell'etichetta «buonista», del tutto coerente con l'esperienza amministrativa di un politico capace di contrattare con i potenti e tenere a bada gli scontenti. Cercando di non scontrarsi con alcuno, se non - chiaramente - con i peggiori pantani del berlusconismo, indicando quattro priorità - ambiente, sicurezza, patto tra generazioni, più il superamento della «politica dei veleni» - profondamente percepite dal senso comune e perciò popolari, ma sufficientemente aperte da poter tenere assieme, ad esempio, le merci da far viaggiare velocemente su Tav con la necessità di cambiare i consumi energetici; o abbastanza generiche da cancellare i conflitti del lavoro per invitare a un nuovo patto tra generazioni come soluzione alla devastante precarietà odierna.
Walter Veltroni è sicuramente l'uomo giusto per un'operazione del genere, per affrontare alcune emergenze (sociali e politiche) senza trasformarle in conflitto generalizzato e affidando il tutto alle capacità di mediazione del leader. La traduzione italiana del modello americano (quello kennedyano, non certo quello bushista), potrà avere un futuro se saprà sfuggire dai tanti agguati che gli apparati e le brurocrazie dei partiti gli tenderanno. Se l'attuale governo - da cui Veltroni non può prescindere - non devasterà con la sua litigiosità il futuro di un partito ideato solo per essere di governo. In quel caso sarà un elemento di chiarificazione del quadro politico e diventerà centrale (in senso proprio) per ogni tipo di mediazione, istituzionale e sociale. E potrà reggere ecumenicamente almeno fino a quando, alla sua sinistra, i nuovi conflitti di classe sapranno darsi una prospettiva generale, anche in versione di sponda politica. Cosa che stenta a vedere la luce. Ma questa non è certo responsabilità di Walter Veltroni.
Corriere della Sera 19.5.07
E Bertinotti cancella il comunismo dalla sua rivista
Secondo Fausto Bertinotti «bisogna avere il coraggio di rischiare».
E lui rischia, toglie dal proprio vocabolario il termine «comunismo», gli dice addio
di Francesco Verderami
La svolta nelle bozze della sua rivista, «Alternative per il socialismo»: Bertinotti abbandona la parola «comunismo» e la sostituisce con «socialismo», «il possibile approdo» della sinistra alternativa
Bertinotti si accomiata dalla parola «comunismo», l'abbandona, non la cita più, e la sostituisce con «socialismo», definito «il possibile approdo» della sinistra alternativa. Per ora la svolta sta nelle bozze della sua rivista,
Alternative per il socialismo, ma è chiaro che l'orizzonte è più ambizioso, che prima o poi a parlare non sarà più il «direttore» Bertinotti, ma il leader storico di Rifondazione. Solo che per arrivare al «possibile approdo» non vuole usare scorciatoie, «è necessaria un'operazione culturale che stia distante dalla quotidianità politica», ha spiegato il presidente della Camera alla sua redazione: «Altrimenti già lo vedo lo scontro tra apparati, la diatriba sugli organismi dirigenti... No, il progetto farebbe la fine del Partito democratico».
Se Bertinotti ha deciso di fare il primo «strappo» attraverso le pagine del suo bimestrale, è perché vuole preparare il gruppo dirigente al distacco da una simbologia che costringe l'area radicale in un recinto angusto.
Solo così potrà sfidare il futuro Pd, «ambire anche a superarlo nei consensi». Mentre progetta l'«Epinay» della sinistra alternativa, racconta di quando «poco più che ventenne fui chiamato a scrivere un pezzo sull'unità sindacale per la rivista di Lelio Basso, Problemi del socialismo». Non a caso il nome del nuovo periodico — che uscirà il primo giugno da Editori Riuniti — incrocia da una parte l'esperienza di Alternative,
foglio culturale del Prc, e dall'altra richiama lo storico giornale di uno dei fondatori del Psiup.
Parla del futuro usando insegnamenti del passato: «Noi siamo per il socialismo di sinistra, non saremo mai socialisti di sinistra». Ragiona sulla «crisi contemporanea della politica italiana» e la misura accostandola alla Francia, «perché la sera in cui ha vinto Nicolas Sarkozy, vedendo le immagini di place de la Concorde in tv, mi è venuta la pelle d'oca»: «Avete notato il suo gesto, la mano tesa a quella parte del Paese che non l'aveva votato e che era stata quindi sconfitta? Lì c'era il senso dello Stato». E certo nessuno a sinistra potrà dubitare di Bertinotti, «però ci sarà un motivo se Max Gallo è rimasto affascinato da Sarkozy».
Insomma, in Francia c'è stata una rivoluzione, a destra. Lui vorrebbe farne una in Italia, a sinistra. Comincia con carta e penna, scrive dell'Europa sfruttandola come metafora. È vero, il presidente della Camera si sofferma sul «vuoto politico» nel Vecchio Continente, ma la sovrapposizione con i problemi nazionali è evidente. Accenna ai «conflitti di sistema», e scorge i limiti della rivolta nel 2005 delle banlieues francesi, «perché questo genere di proteste blocca la capacità degli oppressi di organizzarsi». Poi però, quando nella critica al capitalismo attacca «le classi dirigenti e gli economisti» che «badano solo alla crescita del Pil», si scorge un riferimento alla polemica italiana sul tesoretto, che sta dilaniando il centrosinistra.
Come non bastasse, sostenendo che «la sfida radicale su lavoro e diritti sociali riguarda direttamente la politica e non solo il sindacato», Bertinotti avvisa che «per entrambi è in causa la loro stessa esistenza». Ed ecco che il caso italiano prende il sopravvento, sta nel passaggio in cui il «direttore» descrive l'avvento di «tentazioni neopopuliste», i processi di «spettacolarizzazione e personalizzazione» che «marginalizzano i partiti o li riducono a mero ruolo di supporto», mentre «avanza la centralità dei governi». Aveva promesso che sarebbe stato «per nulla ortodosso», e infatti non scarica solo sulla destra la responsabilità dell'antipolitica: «Anche a sinistra si manifesta una crescente propensione a mutarsi in antipolitica». Bertinotti non la demonizza però, dice che «vista la profondità della crisi, la rinascita della politica non potrà fare a meno di una certa dose di antipolitica».
Ma a fronte di una «mutazione» della sinistra socialdemocratica, l'unica risposta dell'area radicale «per colmare il vuoto» sarà dare «un'adeguata organizzazione ai movimenti»: «Come sinistra alternativa in questi anni abbiamo investito nel movimento. Un'opzione che per un po' ha consentito di ridurre il vuoto della politica e forse anche il gap tra la società e la politica. Ora però l'andamento si è fatto più carsico», anche se «i movimenti non si sono esauriti». Ma questo «magma non può costituirsi in alternativa se non incontra la politica e un'adeguata organizzazione». Serve pertanto «un punto di partenza», che Bertinotti vede nel richiamo alla «questione del socialismo».
Ecco lo «strappo». E sarà pure il «direttore» a scrivere, ma sembra già di sentire il discorso che verrà del leader storico del Prc. Bertinotti per ora si limita a fare i complimenti alla sua redazione: «Siamo riusciti a non citare mai Romano Prodi e Silvio Berlusconi». Se per questo, non è stato mai citato nemmeno il termine «comunismo». «Bene così, dobbiamo guardare avanti».
Associazione Culturale Amore e Psiche
supplemento di "segnalazioni" -
spogli di articoli apparsi sulla stampa e sul web
mercoledì 27 giugno 2007
Repubblica 27.6.07
La parabola del "buonismo"
di Filippo Ceccarelli
Massimo, l'Africa
La politica dei piccoli gesti il buonismo controverso di W.
Su una scena pubblica di cattiverie e volgarità viene esaltata ma non piace a tutti la tolleranza con gli avversari
Impegno nei confronti dei deboli, targhe stradali, incontri di pacificazione. Il modello Roma di Veltroni
Politica, sentimenti e degenerazioni sentimentali, ormai. Potere e benevolenza, conflitto e premura, strategia e morbidezza. Nella giornata in cui il centrosinistra ritrova finalmente un leader, dopo mesi e mesi di vane zuffe varrà la pena di chiedersi come è possibile che Walter Veltroni, preteso buonista per eccellenza, e comunque accreditato fondatore del buonismo, sia riuscito nella straordinaria impresa di fare fuori tutti gli altri senza nemmeno sporcarsi le mani.
«Oddio – ha esclamato Sabrina Ferilli – ancora con questa storia del buonismo!». E tuttavia per una volta converrà accantonare il pur legittimo fastidio dell´attrice, che oltretutto con Veltroni ha un bel debito di riconoscenza, avendola egli difesa, freschissimo sindaco, dagli strali del priore della chiesa di Santa Sabina, sopra il Circo Massimo, allorché la Ferillona volle spogliarsi davanti a 500 mila tifosi che festeggiavano il terzo scudetto della Roma.
E già questo singolare patrocinio, se si vuole, sposta parecchio in là l´orizzonte del buonismo. Categoria politica ormai abbastanza antica, come si intuisce da uno strillo di copertina dell´Espresso, «Buonismo, malattia infantile del centrosinistra», comparsa sotto il faccione del futuro leader del Partito democratico nel febbraio del 1995. Non solo, ma già una decina di anni orsono la parola è entrata nel Lessico Universale della Treccani come: «Ostentazione di buoni sentimenti, di tolleranza e benevolenza verso gli avversari».
Così autorevolmente certificata, si può aggiungere che tale definizione si adatta abbastanza bene al suo indiscusso fondatore. Il quale una volta, a Rieti, appena sceso dall´automobile fu accolto da alcuni giovani militanti di Alleanza nazionale con una pioggia di mutande, si spera - ma non è sicuro - pulite. Un paio di queste mutande lo centrarono in pieno volto. Chi ha assistito alla scena giura che il sorriso di Veltroni fu mite, aperto, indulgente e perfino divertito. Più o meno la stessa grace under pressure, grazia sotto pressione con cui si rivolse a un operatore di Striscia la notizia che aveva preso a tallonarlo da giorni: «Senta - gli disse il sindaco - a questo punto credo proprio che io e lei dovremo sposarci».
L´agiografia veltroniana, d´altra parte, si configura come un genere giornalistico particolarmente contagioso che arriva a lambire addirittura Il Secolo d´Italia (letto, s´immagina, dai lanciatori di slip). Ma il personaggio è obiettivamente garbato. Di più, è una persona decisamente piacevole. Ma la politica, come diceva De Mita, è la politica; e quindi vive anche - e mai come oggi - di seduzioni e rappresentazioni che travalicano la sfera privata dei suoi protagonisti. Per cui Veltroni, che pure teorizza «la forza dei piccoli gesti», certamente ne compie a iosa: e perciò rinuncia alla scorta, cede il palco riservato dell´Opera agli studenti del Conservatorio, converte i regali di compleanno nell´acquisto di un videoproiettore per i minori incarcerati. Un giorno, non lontano dalla moschea, ha visto un ragazzo che abbandonava per terra una bottiglia di birra: e allora il sindaco ha fatto fermare la macchina, è sceso, ha avvicinato il giovane facendogli raccogliere la bottiglia per deporla in un cestino.
E comunque: non è il tratto personale in discussione. Molto più interessante, semmai, è indagare sul trionfo del preteso buonismo veltroniano su una scena pubblica sempre più connotata da cattiverie, maleducazioni e volgarità.
Da questo punto di vista il «modello Roma», dove un asilo nido è stato ribattezzato «Coccole & Co», dice molto più di quello che gli analisti sociali freddamente classificano come «politiche simboliche». Un vero e proprio «pozzo di San Patricio», parafrasando il titolo del più buonista dei romanzi veltroniani: lapidi e targhe mirate; intitolazione di vie e parchi in segno di riconciliazione; ricerca di «eroi» e sensibilità al dolore dei personaggi della cronaca (premiazioni, case trovate, funerali pagati); permessi retribuiti ai dipendenti comunali che facciano volontariato; impegno personale del sindaco nei confronti di vecchi, bambini, disabili, esuli. Poi sì, certo, si esagera pure - e ai romani, che i loro problemi continuano sempre ad averceli, non è che siano tanto disposti ad esultare all´unisono con il loro sindaco per l´insperato ritrovamento del cane «Fiocco». Ma pazienza.
Lo stesso Veltroni è intervenuto più volte sul suo stesso buonismo. L´ha fatto, c´è anche da dire, con appuntita sottigliezza lasciando com´è ovvia da parte Peter Pan e San Francesco, due fra i suoi più gettonati ispiratori, ma La Rochefoucauld («Gli sciocchi non hanno la stoffa per essere buoni») e addirittura Machiavelli che scrive: «Però che a un popolo licenzioso e tumultuoso gli può da un uomo buono esser parlato, e facilmente può esser ridotto nella via buona».
Si tratta in effetti di un´antica risorsa del comando, nella sua accezione tenue, mite, soffice, e però spesso anche mascherata, alla Forlani, per intendersi, non a caso fiabescamente soprannominato «Il Coniglio Mannaro». Eppure, nel corso del tempo, Veltroni non ha mai troppo apprezzato di essere definito come buonista: «Visto che ho la temperatura bassa - ha spiegato una volta - mi rodo il fegato e domino la rabbia. Ma non vorrei che la gentilezza fosse scambiata per qualche cos´altro». E già: «Dal buono al fesso - ha integrato la moglie Flavia, pure consultata sull´argomento - ci vuole un attimo». C´è da dire che quest´attimo venne bruciato da Berlusconi nell´ormai remoto 1995: «Veltroni è un coglione» gli scappò detto in un piano-bar di Cernobbio. Poi rettificò, i giornalisti avevano sentito male. La rettifica che lo aspetta nei prossimi mesi rischia comunque di essere per lui più complicata.
Più scabroso è la dinamica interrelazionale, se così si può dire, con l´antagonista storico di Veltroni, e cioè D´Alema. Perché il buonismo nasce anche in chiaroscuro, in controluce, in controtendenza e in alternativa a un supposto - e anche in quel caso abbastanza documentabile - «cattivismo» dell´attuale ministro degli Esteri. Ha detto Walter diversi anni fa: «Massimo ha una forma di comunicazione molto dura, molto severa, un po´ sprezzante nei confronti degli altri, e questo non aiuta». Decisamente no, a giudicare da come sta per finire il torneo per la guida del Partito democratico. Anche se poi, ed è sempre Veltroni a parlare, «scavando, probabilmente si scoprirebbe che io non sono poi così buono». Probabilmente. Per quanto intima, la politica resta sempre un po´ ambigua.
Repubblica 27.6.07
L'evoluzione e l´incerto futuro dell'uomo
di Luca e Franceso Cavalli-Sforza
Il segreto della vita
Se all´origine non c´è un intervento divino
Il principio è l´autoriproduzione
Nell´ipotesi plausibile che ci siamo formati da soli, non si sa cosa potremo diventare
Un tempo si pensava che da sempre tutto avesse avuto la stessa forma
Darwin notò che le stesse specie in luoghi diversi mutavano aspetto
C´è stato un tempo, nemmeno molto lontano, in cui era convinzione generale che tutto ciò che abbiamo intorno fosse esistito in forme fisse e immutabili da sempre: che le piante, gli animali, gli stessi esseri umani avessero avuto l´aspetto con cui li conosciamo fin dal momento della loro comparsa sulla Terra, per intervento divino. C´era stato anche chi, nell´antichità, come Lucrezio, aveva affermato che molte varietà di esseri viventi ormai scomparse dovevano avere abitato il mondo in tempi assai lontani, ma erano affermazioni guardate con sospetto. Come potevamo sapere?
Dopotutto, le testimonianze delle civiltà del passato parlavano di uomini in tutto simili a noi e di animali ben noti. Il testo più antico che si conoscesse allora, la Bibbia, diceva che sette giorni erano stati sufficienti a dare forma al mondo e a tutto ciò che lo abita, compreso l´uomo.
Per secoli e per millenni, gli esseri umani avevano continuato a costruire sulle rovine dei loro predecessori. In Europa, i borghi medievali erano sorti sulle rovine delle città romane, e le città moderne sui resti dei centri medievali. Poi giunse la rivoluzione industriale e si cominciò a scavare, per costruire ferrovie e strade, fabbriche e palazzi. Vennero così ritrovamenti imprevisti. Quando furono portate alla luce le prime ossa di dinosauri, chiaramente diverse da quelle di ogni animale conosciuto, si disse che non potevano appartenere ad animali esistiti un tempo e in seguito scomparsi, perché era impensabile che Dio avesse creato una specie vivente per poi scoprire di essersi sbagliato e portarla all´estinzione.
Sempre ragionando in questo modo, quando furono ritrovate, nel 1856, le prime ossa di uomini di Neandertal, che sono molto più spesse e robuste delle nostre, furono attribuite a grandi scimmie o a patologie dell´apparato scheletrico umano.
Ma le scoperte proseguirono, e col tempo divenne impossibile negare che il pianeta era stato abitato, in un lontano passato, da una miriade di piante e di animali parecchio diversi da quelli che abbiamo intorno oggi, e anche da uomini di aspetto profondamente diverso dal nostro. Nel frattempo, i geologi si erano resi conto, seguendo altre vie, che la Terra doveva essere immensamente più antica dei seimila anni computabili in base alla Sacra Scrittura.
Si trovarono altri testi, ben più vecchi della Bibbia. Nel ‘700 si cominciò a stimare, per il pianeta, un´età di quasi centomila anni, o maggiore ancora. Oggi parliamo di circa 4,5 miliardi di anni.
Fra il 1831 e il 1836, un giovane naturalista inglese, Charles Darwin, traversava il mondo su un brigantino della marina britannica diretto a effettuare rilievi cartografici dell´America meridionale. Nel corso del viaggio ebbe modo di osservare una molteplicità di piante e di animali: ne raccolse campioni, li analizzò e si rese conto che le stesse specie, vivendo in luoghi separati e lontani l´uno dall´altro, avevano assunto caratteri differenti, che variavano a seconda di ciò di cui si nutrivano e dell´ambiente in cui abitavano. Ne derivò l´idea che le specie viventi cambino nel corso del tempo, sviluppando caratteristiche diverse, e che sopravvivano gli individui e le popolazioni che meglio riescono a procurarsi il necessario nutrimento e a riprodursi, risultando così meglio adattate all´ambiente in cui vivono. All´opposto, gli individui e le popolazioni che hanno maggiori difficoltà a crescere e a riprodursi tenderanno a scomparire, nel volgere delle generazioni. E l´ambiente, quindi, a compiere una selezione fra le diverse specie e fra le varie popolazioni e individui di una stessa specie. Poiché l´ambiente cambia di continuo, anche le caratteristiche dei viventi cambiano, nel corso del tempo.
Darwin chiamò questo processo selezione naturale. Non era ancora chiaro come nascessero questi cambiamenti, ma si sapeva che gli agricoltori e gli allevatori di bestiame selezionavano e incrociavano fra loro le varietà più promettenti di piante e di animali, per migliorarne la produttività e altre caratteristiche, operando un processo di selezione artificiale per molti aspetti simile a quello che in natura avviene spontaneamente. In Inghilterra, i due secoli precedenti a Darwin avevano visto grandi progressi in agronomia e zootecnia.
Un altro naturalista inglese, Alfred Russell Wallace, che pure aveva lavorato a lungo in America meridionale, giungeva negli stessi anni a conclusioni analoghe a quelle di Darwin, benché, molto più giovane di lui, non le avesse sviluppate con ampiezza paragonabile. I tempi erano ormai maturi per introdurre l´idea che le specie non sono immutabili, e quando Darwin pubblicò, nel 1859, il risultato dei suoi studi, con il titolo Sull´origine delle specie per selezione naturale, l´opera andò esaurita in un giorno.
Era nata la scienza dell´evoluzione. Suscitò controversie così vivaci da non essersi ancora spente oggi.
In cosa consiste l´evoluzione? Oggi la definiamo come il cambiamento continuo ed inevitabile delle specie nel corso del tempo. E bene chiarire subito che "evoluzione" non significa necessariamente né "miglioramento" né "progresso": si sono osservati parecchi casi di regressione pura e semplice, nel corso della storia, e deviazioni che hanno dato origine a rami nuovi, in seguito scomparsi, anche in popolazioni della linea umana.
Evoluzione significa prima di tutto differenziazione progressiva. Gli esseri viventi cambiano nel corso del tempo: compaiono forme nuove che possono coesistere a lungo accanto alle più antiche e che a loro volta vanno incontro a nuovi cambiamenti.
Basti pensare alla straordinaria varietà delle piante da fiore o degli uccelli, o dei dinosauri riportati alla luce negli ultimi duecento anni. L´evoluzione comporta quindi trasformazione e un aumento della varietà disponibile, a cui si accompagna spesso, ma non sempre, un aumento di complessità. Valga ad esempio l´estrema raffinatezza raggiunta da organi quali l´occhio o l´orecchio, nell´arco di centinaia di milioni di anni, o lo sviluppo del cervello umano, che ci rende capaci di pensieri e attività sconosciute ai tempi in cui i nostri antenati non avevano ancora imparato a usare il fuoco, o a rompere con pietre le ossa di animali per succhiarne il midollo. All´opposto, molti parassiti si specializzano assai, semplificando o perdendo le parti inutili e perfezionando quelle che permettono loro di attaccarsi ai loro ospiti e di penetrarvi. Una volta entrati, li costringono a moltiplicare i parassiti, a proprio danno, e a spargerne i figli all´esterno.
Evoluzione significa, infine, sviluppo di capacità di interazione con l´ambiente. È questo, in definitiva, a decidere del successo di una specie o della sua scomparsa. I grandi uccelli senz´ali che abitavano la Nuova Guinea nella preistoria sono stati portati all´estinzione quando nel loro ambiente sono sbarcati uomini armati di lance di legno con la punta indurita al fuoco.
Alla stessa stregua, intere popolazioni umane sono scomparse quando nel loro ambiente sono penetrati bacilli, come i virus dell´influenza o del morbillo, contro cui non erano in grado di difendersi.
Cosa rende possibile l´evoluzione? La risposta semplicissima è: la vita stessa. Qual è la caratteristica principale della vita?
Non è il movimento: le piante sono vive ma non si muovono. Non è la complessità: un´auto è complessa e si muove, ma non è viva. Non è nemmeno la capacità di nascere, crescere e morire: anche una roccia "nasce", per esempio in un´eruzione vulcanica; un cristallo può crescere; e ogni cosa prima o poi ha fine. La caratteristica esclusiva della vita è l´autoriproduzione: la vita riproduce se stessa, se trova condizioni adeguate, e può assumere una enorme varietà di forme, come testimonia il mondo che abbiamo intorno. Anche un cristallo può formare copie di se stesso, in condizioni opportune, ma tutte avranno struttura identica al genitore. Un batterio ha struttura identica al genitore, ma nel corso delle generazioni può cambiare, e pur mostrando una complessità che nel cristallo non esiste continua a riprodursi quasi identico a se stesso, e simultaneamente ad evolvere.
Lo studio della vita ha fatto passi da gigante dai tempi di Darwin, e le ragioni e i modi del cambiamento oggi sono ampiamente noti. Ne parleremo nei prossimi articoli, perché si tratta degli eventi che rappresentano il motore stesso dell´evoluzione. Non sappiamo ancora come la vita abbia avuto origine, né se sia sorta sulla Terra o sia venuta dallo spazio su di un meteorite. Se è sorta sulla Terra, deve esserci voluto parecchio tempo perché potesse comparire, perché la nascita della vita deve essere un evento estremamente raro. Questo non significa che sia apparsa solo qui: vuole solo dire che c´è stato un luogo e un momento in cui una stringa di molecole è riuscita ad agganciare alcuni atomi, alcuni pezzi da costruzione, nell´ambiente circostante, e ad organizzarli intorno a sé in modo da formare una copia esatta, una sorta di carta carbone, di se stessa.
C´è una riflessione che potrà disturbare chi non accetta che la vita possa avere davvero avuto origine da sola, ma vuole che sia sorta per un intervento esterno, extraterrestre, e che non abbia trovato da sé la sua strada, ma si sia sviluppata seguendo un piano preordinato, magari addirittura in vista di un finale già scritto. È una semplice considerazione: se davvero la vita «ha fatto tutto da sola», cosa che non è dimostrata e forse non è nemmeno dimostrabile, ma è perfettamente compatibile con ciò che sappiamo, allora non si sa dove stiamo andando, non si sa cosa potremo diventare, nessun piano guida la storia della vita, e ciò che sarà dell´umanità e del pianeta su cui si è imposta come specie dominante dipende in larga misura dalle scelte che faremo. Portiamo con noi nella vita, insomma, piena responsabilità per ciò che siamo e per ciò che diventeremo.
Questa incertezza disturba il senso di sicurezza di molti, e li spinge a cercare una figura paterna che insegni e diriga, e dicendo loro dove andare li sottragga a questa responsabilità. Ha fondamento questa aspirazione ad essere guidati? Nessuno può dimostrarlo, anche se molte menti eccelse ci hanno provato.
Ciascuno deve scegliere a cosa prestare fede al riguardo, ma negare che vi sia evoluzione significa rinunciare alla nostra capacità di ragionamento, e a tutto quanto sappiamo.
Corriere della Sera 27.6.07
La Cgil e la grande paura di farsi scavalcare dal Prc
di Enrico Marro
«Non scopriamo il fianco sinistro» La Cgil in gara con Rifondazione
Epifani si prepara a una «firma provvisoria». Poi vuole il referendum
ROMA — All'ottimismo di Romano Prodi e di Tommaso Padoa-Schioppa si è contrapposto per tutto il giorno il pessimismo della Cgil e di Rifondazione comunista. E non è stato solo per bilanciare i messaggi del presidente del Consiglio e del ministro dell'Economia, ma anche per segnalarsi l'un l'altro — il sindacato di Guglielmo Epifani e il partito di Franco Giordano — che, nel campo di battaglia delle pensioni e del lavoro, nessuno avrebbe lasciato scoperto il fronte sinistro. Giordano e il ministro della Solidarietà sociale, Paolo Ferrero, hanno cominciato dalla mattina presto a frenare rispetto a ipotesi di accordo, a ribadire che lo «scalone Maroni» non poteva semplicemente essere ammorbidito come spiegava il governo, ma che andava «abolito, come prevede il programma ». A quel punto la Cgil ha cominciato a non sentirsi più garantita rispetto agli impegni presi dalla Rifondazione solo qualche settimana fa. E a dire il vero anche la Cisl e la Uil sono diventate sospettose, anche se a loro un eventuale scavalcamento a sinistra da parte dei massimalisti creerebbe molti meno problemi.
Ma andiamo con ordine.
Un paio di settimane fa i vertici di Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato i capigruppo delle sinistre radicali (Rifondazione, Pdci, Verdi e Sinistra democratica) ottenendo da tutti la garanzia che un eventuale accordo dei sindacati col governo non sarebbe stato rimesso in discussione in Parlamento e nelle piazze. Come dire: «Quello che va bene a voi andrà bene anche a noi e non vi creeremo problemi». Poi però sono successe due cose che hanno un po' cambiato il quadro.
Prima il flop della manifestazione delle sinistre radicali a piazza del Popolo contro la visita del presidente americano Bush a Roma e secondo la candidatura di Walter Veltroni alla guida del Partito democratico. Entrambe le cose hanno rafforzato, soprattutto in Rifondazione, le posizioni più intransigenti, quelle che vogliono «recuperare il rapporto con i movimenti», «l'insediamento sociale» del partito e la sua connotazione di lotta. Posizioni che hanno fatto leva anche sul preoccupante calo di consensi registrato da Rifondazione alle elezioni amministrative. Insomma, dalle parti di Giordano è suonato più di un campanello d'allarme sul fatto che la permanenza al governo è rischiosa. Questo non significa assolutamente che Rifondazione pensi di uscire, ma che appunto vuole essere ancora di più «partito di lotta e di governo».
Queste cose in Cgil le sanno benissimo, non fosse altro perché hanno in casa un pezzo di Rifondazione. Anzi, allargando lo sguardo a tutte le sinistre radicali, almeno metà del gruppo dirigente di Corso Italia fa riferimento a formazioni che stanno alla sinistra dei Ds e domani del Partito democratico. Mezza segreteria guarda alla Sinistra democratica di Mussi e Salvi. E lì guardano anche i vertici di categorie importanti come la Funzione pubblica, la Scuola, l'Agro Industria. Per non parlare della Fiom, i metalmeccanici, che hanno in segreteria Giorgio Cremaschi, esponente della sinistra estrema di Rifondazione.
Ecco perché l'insistenza di Giordano e Ferrero per «l'abolizione» dello scalone non è passata inosservata a piani alti della Cgil. Ed è montato il sospetto che le garanzie offerte qualche settimana fa non fossero più tanto sicure. Meglio premunirsi. L'altro ieri Epifani ha tastato il polso dell'organizzazione consultando la «delegazione alla trattativa» che, tanto per dare l'idea, è composta da tutti i segretari di categoria e tutti i segretari regionali. Non solo. Per oggi alle 15 è convocato il direttivo, cioè il parlamentino della Cgil, che siederà praticamente in seduta permanente per valutare l'accordo. Epifani, insomma, vuole garantirsi il più possibile all'interno. E comunque, in uno degli ultimi incontri a Palazzo Chigi, ha annunciato al governo che la Cgil rispetto a un'eventuale intesa metterà per il momento una sigla provvisoria, in attesa del referendum dei lavoratori. Solo dopo il loro sì, Epifani firmerà l'intesa. Ed è proprio il referendum la soluzione che, come nel '95, dovrebbe consentire alla Cgil di confermare l'accordo (a maggioranza) e evitare che il no dei metalmeccanici (ci fu già sulla riforma Dini) e di altri pezzi della confederazione metta in discussione gli equilibri interni. Lo stesso referendum al quale potrebbero appellarsi Giordano per contenere i dissensi nel partito. Ma ieri sera Epifani ha chiesto anche un'ultima garanzia. Direttamente a Prodi: che l'accordo venga blindato con un decreto o con un disegno di legge sul quale porre la questione di fiducia. E impedire quindi ogni rilancio di Rifondazione.
l'Unità 27.6.07
Meneghello, un’altra lingua un’altra Resistenza
di Stefano Guerriero
È MORTO IERI, a 85 anni, lo scrittore vicentino, autore negli anni 60 di Libera nos a malo e I piccoli maestri. Lo scavo nel dialetto, la «leggerezza» calviniana e la condizione di outsider caratterizzano la sua opera e la sua testimonianza sul biennio 43-45
Delle qualità che Calvino proponeva per il millennio che ormai stiamo vivendo, Luigi Meneghello aveva indubbiamente in modo cospicuo la leggerezza. Una leggerezza acuta e divertita che tuttavia non presuppone disimpegno o distacco dalla realtà: tutt’altro.
Questa leggerezza in anticipo sui tempi è uno dei due motivi per cui si è tardato forse fino alla metà degli anni Ottanta a riconoscere il suo valore, nonostante avesse esordito con due libri innovativi di grande portata: Libera nos a malo (Feltrinelli 1963), romanzo, o non romanzo che sia, linguistico e sociologico sulla propria infanzia e sul mutamento della società contadina e del suo dialetto, e I piccoli maestri (Feltrinelli 1964), la più celebre narrazione resistenziale, anch’essa a sfondo autobiografico. L’altro motivo della tardiva scoperta è la sua qualità di outsider: Meneghello ha insegnato letteratura italiana in Inghilterra all’Università di Reading dal 1947 e questo faceva di lui forse un provinciale, un marginale agli occhi dell’establishment letterario italiano. Ma la distanza certo non gli ha nuociuto: la sua scrittura muove da una lontananza nello spazio e nel tempo; è animata da un ripensamento (degli anni della guerra e del Ventennio fascista) che non diventa malinconica letteratura del ricordo ma lucida volontà di comprendere e anche di denunciare i propri e altrui errori, sia pure evocati con affetto. Sta di fatto che nel ’63 a parte i recensori d’ufficio pochi leggono Libera nos a malo, che pure era al passo con il clima neoavanguardistico, per il suo essere tutto giocato sullo «sfasamento tra il mondo delle parole e quello delle cose»; per il suo scavo nel dialetto che come le lingue specifiche degli occhi e di altri sensi, «è sempre incavicchiato alla realtà, per la ragione che è la cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare». Anche I piccoli maestri, singolarmente scritto nell’anno di morte di Fenoglio, l’altro grande cantore non ideologico della Resistenza, si afferma a fatica, con una prima riedizione, drasticamente riveduta dall’autore, nel ’76 e via via altre edizioni tra cui una scolastica nell’88.
I piccoli maestri inizia genialmente con l’atto di viltà più grave per un combattente: l’abbandono dell’arma, un parabellum lasciato in una crepa nella roccia durante un rastrellamento. E perché non ci siano dubbi l’autore mette subito in chiaro che a quei tempi di armi ne perdevano di continuo che in realtà «non eravamo mica buoni, a fare la guerra». È un libro tutto scritto in chiave antieroica, tutto contro la vulgata resistenziale e insieme tutto a favore delle ragioni della Resistenza, nonostante gli errori materiali e ideali che pure Meneghello vi riconosce. Un libro anticonformista. Si svolge tra l’Altipiano di Asiago e il Veneto, dove ha operato la singolare brigata del piccolo maestro Toni Giuriolo negli anni della guerra civile (guerra civile è un termine che ritorna di continuo nella narrazione: Meneghello non ha paura delle parole). Nelle vicende di questa pattuglia di «deviazionisti crociani di sinistra», come li definisce ironicamente l’autore, c’è la paura e il fascino della morte violenta, l’eccitazione dei rastrellamenti, ma anche le azioni fallite, il tragico spararsi addosso per errore: fatti dopo i quali «uno si sentiva soldato, frate, fibra dell’universo, e mona». Il piglio antiretorico è sistematico e coinvolge tutti i miti giovanili, compresi i miti culturali. All’eroismo viene preferito l’empirismo: «l’eroismo è più bello, ma ha un difetto, che non è veramente una forma della vita. L’empirismo è una serie di sbagli, e più sbagli e più senti che stai crescendo, che vivi». Un empirismo che è una differenza sostanziale con l’eroismo mortuario delle milizie di Salò. Contemporaneamente c’è la sincera e difficile rievocazione dell’entusiasmo giovanile, della fascinazione dell’avventura che si concretizza ad esempio nell’adorazione delle armi, odiate perché poche, brutte e vecchie, ma comunque sacre.
La compresenza dello sguardo del giovane di allora e dell’uomo maturo degli anni sessanta, entrambi rivolti sull’oggetto Resistenza, senza che l’uno falsifichi l’altro, è l’elemento più mirabile dei Piccoli maestri. Tutto è tenuto insieme con un’abilissima ironia, insieme lucida e affettuosa. La stessa ironia che caratterizza tutti i libri di Meneghello, da Fiori italiani (Rizzoli 1976) sull’educazione in tempo di fascismo e oltre, a Bau-sète (Rizzoli 1988), gustosa rievocazione del dopoguerra e della sua attività per il Partito d’Azione, il partito perfetto «per cui non votarono neanche le nostre fidanzate», fino alle ricerche linguistiche di Jura (Garzanti 1987) e oltre.
Meneghello è ormai consacrato come un classico, un fatto testimoniato dai volumi Rizzoli delle Opere e dal fiorire di edizioni, che certo come sempre in questi casi aumenterà ancora. È auspicabile che questo fiorire favorisca una ricezione ampia e completa dell’autore. Attualmente si ha l’impressione che sia un po’ la primizia sulla quale il critico-linguista sperimenta le proprie ricette. Certo i linguisti, da Giulio Lepschy a Cesare Segre a Maria Corti, hanno il merito indiscusso di aver difeso questo autore quando pochi lo conoscevano veramente. La sperimentazione linguistica, il lavoro di ricerca sulla lingua e sul dialetto, le contaminazioni con l’inglese sono dati imprescindibili per la comprensione del valore formale della sua scrittura.
Tuttavia è vero che in Meneghello c’è un fondo di passione e di volontà di comprendere che lo rendono anche un testimone eccezionale e sostanzialmente inedito dei decenni più difficili della storia italiana e della Liberazione. Insieme a Fenoglio, al Calvino del Sentiero dei nidi di ragno e, perché no, a Tiro al piccione di Giose Rimanelli, Meneghello può essere la via di accesso privilegiata alla comprensione di che cosa è stata veramente la Resistenza e la guerra civile. Sono argomenti che meritano attenzione al di fuori della cerchia degli specialisti.
il Riformista 26.6.07
Nigeria, il dramma dei bimbi-cavia
di Paolo Soldini
È il 1996. In Nigeria si diffonde un'epidemia di meningite che provoca, in poche settimane, 15mila morti, soprattutto bambini. II governo di Abuja chiede aiuto all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e alle industrie farmaceutiche internazionali. Una risponde: la Pflzer, l'azienda americana famosa per il Viagra. Un team di medici inviati da New York si mette al lavoro in uno degli ospedali da campo in cui vengono accolti i piccoli malati. Hanno un farmaco nuovo, si chiama Trovan, appena prodotto dai laboratori della Pfizer. Nell'ospedale c'è anche un'équipe di Medici senza frontiere (Msf), ma né a loro né ai genitori dei bambini né a chiunque altro viene chiesto se sia il caso o no di testare il farmaco su 200 piccoli malati. I medici del team americano avrebbero anche nascosto ai familiari il fatto che nello stesso ospedale i bambini potevano essere curati con gli antibiotici di cui gli operatori di Msf erano abbondantemente fomiti.
Insomma: duecento cavie umane, trattate come cavie e basta in nome del profitto. Duecento bambini usati come oggetti senza valore per scoprire che la medicina non funziona e, soprattutto, che ha effetti collaterali micidiali. Dei 200 piccoli malati, infatti, I11 muoiono, molti restano paralizzati, molti perdono la vista, altri l'udito. Tutti, senza eccezioni, soffrono conseguenze gravi.
Oggi sulla vicenda, che ricorda in modo impressionante la trama dell'ultimo romanzo di John Le Carré The Constant Gardercer (e del film che ne è stato tratto), ad Abuja comincia un processo che potrebbe fare storia. II governo nigeriano, dopo aver a lungo esitato di fronte alle richieste disperate dei genitori delle piccole vittime, si decide a chiedere alla Pfizer un risarcimento di 7 miliardi di dollari. L'entità della richiesta è motivata anche da un "effetto collaterale" che nessuno avrebbe mai potuto prevedere: nel nord del Paese, dominato dai clan musulmani, dopo lo scoppio dello scandalo si è diffusa la fobia delle medicine fornite "dagli occidentali", i quali, secondo i fanatici islamici, starebbero operando una vera e propria sterilizzazione di massa per cancellare dal Paese tutti i seguaci di Allah. Molti ambulatori sono stati distrutti e nella regione viene boicottata violentemente la distribuzione di ogni vaccino che venga dall'estero. La conseguenza è che, secondo l'Oms, la poliomielite e altre malattie infettive starebbero infuriando di nuovo in zone da cui erano state sradicate.
La Pfizer si difende sostenendo che non si può affermare con certezza che la trovafexocina, il principio attivo del Trovan, sia stato l'effettiva causa delle morti e delle gravissime menomazioni. Ma a smentirli c'è, oltre al modo clandestino con cui il farmaco veniva somministrato, un preciso warming lanciato nel '99 dalla Food and drug amministration (Fda). Secondo l'ente federale statunitense, l'uso del Trovan, che non è mai stato approvato per il trattamento della meningite, è "legato a tossicità epatica e mortalità". L'elenco delle controindicazioni pubblicato dal British Medical Journal (Bmj) d'altra parte riempie pagine e pagine: ci sono scritti tutti i motivi per cui quella medicina non avrebbe mai dovuto essere somministrata a 200 poveri innocenti.
La parabola del "buonismo"
di Filippo Ceccarelli
Massimo, l'Africa
La politica dei piccoli gesti il buonismo controverso di W.
Su una scena pubblica di cattiverie e volgarità viene esaltata ma non piace a tutti la tolleranza con gli avversari
Impegno nei confronti dei deboli, targhe stradali, incontri di pacificazione. Il modello Roma di Veltroni
Politica, sentimenti e degenerazioni sentimentali, ormai. Potere e benevolenza, conflitto e premura, strategia e morbidezza. Nella giornata in cui il centrosinistra ritrova finalmente un leader, dopo mesi e mesi di vane zuffe varrà la pena di chiedersi come è possibile che Walter Veltroni, preteso buonista per eccellenza, e comunque accreditato fondatore del buonismo, sia riuscito nella straordinaria impresa di fare fuori tutti gli altri senza nemmeno sporcarsi le mani.
«Oddio – ha esclamato Sabrina Ferilli – ancora con questa storia del buonismo!». E tuttavia per una volta converrà accantonare il pur legittimo fastidio dell´attrice, che oltretutto con Veltroni ha un bel debito di riconoscenza, avendola egli difesa, freschissimo sindaco, dagli strali del priore della chiesa di Santa Sabina, sopra il Circo Massimo, allorché la Ferillona volle spogliarsi davanti a 500 mila tifosi che festeggiavano il terzo scudetto della Roma.
E già questo singolare patrocinio, se si vuole, sposta parecchio in là l´orizzonte del buonismo. Categoria politica ormai abbastanza antica, come si intuisce da uno strillo di copertina dell´Espresso, «Buonismo, malattia infantile del centrosinistra», comparsa sotto il faccione del futuro leader del Partito democratico nel febbraio del 1995. Non solo, ma già una decina di anni orsono la parola è entrata nel Lessico Universale della Treccani come: «Ostentazione di buoni sentimenti, di tolleranza e benevolenza verso gli avversari».
Così autorevolmente certificata, si può aggiungere che tale definizione si adatta abbastanza bene al suo indiscusso fondatore. Il quale una volta, a Rieti, appena sceso dall´automobile fu accolto da alcuni giovani militanti di Alleanza nazionale con una pioggia di mutande, si spera - ma non è sicuro - pulite. Un paio di queste mutande lo centrarono in pieno volto. Chi ha assistito alla scena giura che il sorriso di Veltroni fu mite, aperto, indulgente e perfino divertito. Più o meno la stessa grace under pressure, grazia sotto pressione con cui si rivolse a un operatore di Striscia la notizia che aveva preso a tallonarlo da giorni: «Senta - gli disse il sindaco - a questo punto credo proprio che io e lei dovremo sposarci».
L´agiografia veltroniana, d´altra parte, si configura come un genere giornalistico particolarmente contagioso che arriva a lambire addirittura Il Secolo d´Italia (letto, s´immagina, dai lanciatori di slip). Ma il personaggio è obiettivamente garbato. Di più, è una persona decisamente piacevole. Ma la politica, come diceva De Mita, è la politica; e quindi vive anche - e mai come oggi - di seduzioni e rappresentazioni che travalicano la sfera privata dei suoi protagonisti. Per cui Veltroni, che pure teorizza «la forza dei piccoli gesti», certamente ne compie a iosa: e perciò rinuncia alla scorta, cede il palco riservato dell´Opera agli studenti del Conservatorio, converte i regali di compleanno nell´acquisto di un videoproiettore per i minori incarcerati. Un giorno, non lontano dalla moschea, ha visto un ragazzo che abbandonava per terra una bottiglia di birra: e allora il sindaco ha fatto fermare la macchina, è sceso, ha avvicinato il giovane facendogli raccogliere la bottiglia per deporla in un cestino.
E comunque: non è il tratto personale in discussione. Molto più interessante, semmai, è indagare sul trionfo del preteso buonismo veltroniano su una scena pubblica sempre più connotata da cattiverie, maleducazioni e volgarità.
Da questo punto di vista il «modello Roma», dove un asilo nido è stato ribattezzato «Coccole & Co», dice molto più di quello che gli analisti sociali freddamente classificano come «politiche simboliche». Un vero e proprio «pozzo di San Patricio», parafrasando il titolo del più buonista dei romanzi veltroniani: lapidi e targhe mirate; intitolazione di vie e parchi in segno di riconciliazione; ricerca di «eroi» e sensibilità al dolore dei personaggi della cronaca (premiazioni, case trovate, funerali pagati); permessi retribuiti ai dipendenti comunali che facciano volontariato; impegno personale del sindaco nei confronti di vecchi, bambini, disabili, esuli. Poi sì, certo, si esagera pure - e ai romani, che i loro problemi continuano sempre ad averceli, non è che siano tanto disposti ad esultare all´unisono con il loro sindaco per l´insperato ritrovamento del cane «Fiocco». Ma pazienza.
Lo stesso Veltroni è intervenuto più volte sul suo stesso buonismo. L´ha fatto, c´è anche da dire, con appuntita sottigliezza lasciando com´è ovvia da parte Peter Pan e San Francesco, due fra i suoi più gettonati ispiratori, ma La Rochefoucauld («Gli sciocchi non hanno la stoffa per essere buoni») e addirittura Machiavelli che scrive: «Però che a un popolo licenzioso e tumultuoso gli può da un uomo buono esser parlato, e facilmente può esser ridotto nella via buona».
Si tratta in effetti di un´antica risorsa del comando, nella sua accezione tenue, mite, soffice, e però spesso anche mascherata, alla Forlani, per intendersi, non a caso fiabescamente soprannominato «Il Coniglio Mannaro». Eppure, nel corso del tempo, Veltroni non ha mai troppo apprezzato di essere definito come buonista: «Visto che ho la temperatura bassa - ha spiegato una volta - mi rodo il fegato e domino la rabbia. Ma non vorrei che la gentilezza fosse scambiata per qualche cos´altro». E già: «Dal buono al fesso - ha integrato la moglie Flavia, pure consultata sull´argomento - ci vuole un attimo». C´è da dire che quest´attimo venne bruciato da Berlusconi nell´ormai remoto 1995: «Veltroni è un coglione» gli scappò detto in un piano-bar di Cernobbio. Poi rettificò, i giornalisti avevano sentito male. La rettifica che lo aspetta nei prossimi mesi rischia comunque di essere per lui più complicata.
Più scabroso è la dinamica interrelazionale, se così si può dire, con l´antagonista storico di Veltroni, e cioè D´Alema. Perché il buonismo nasce anche in chiaroscuro, in controluce, in controtendenza e in alternativa a un supposto - e anche in quel caso abbastanza documentabile - «cattivismo» dell´attuale ministro degli Esteri. Ha detto Walter diversi anni fa: «Massimo ha una forma di comunicazione molto dura, molto severa, un po´ sprezzante nei confronti degli altri, e questo non aiuta». Decisamente no, a giudicare da come sta per finire il torneo per la guida del Partito democratico. Anche se poi, ed è sempre Veltroni a parlare, «scavando, probabilmente si scoprirebbe che io non sono poi così buono». Probabilmente. Per quanto intima, la politica resta sempre un po´ ambigua.
Repubblica 27.6.07
L'evoluzione e l´incerto futuro dell'uomo
di Luca e Franceso Cavalli-Sforza
Il segreto della vita
Se all´origine non c´è un intervento divino
Il principio è l´autoriproduzione
Nell´ipotesi plausibile che ci siamo formati da soli, non si sa cosa potremo diventare
Un tempo si pensava che da sempre tutto avesse avuto la stessa forma
Darwin notò che le stesse specie in luoghi diversi mutavano aspetto
C´è stato un tempo, nemmeno molto lontano, in cui era convinzione generale che tutto ciò che abbiamo intorno fosse esistito in forme fisse e immutabili da sempre: che le piante, gli animali, gli stessi esseri umani avessero avuto l´aspetto con cui li conosciamo fin dal momento della loro comparsa sulla Terra, per intervento divino. C´era stato anche chi, nell´antichità, come Lucrezio, aveva affermato che molte varietà di esseri viventi ormai scomparse dovevano avere abitato il mondo in tempi assai lontani, ma erano affermazioni guardate con sospetto. Come potevamo sapere?
Dopotutto, le testimonianze delle civiltà del passato parlavano di uomini in tutto simili a noi e di animali ben noti. Il testo più antico che si conoscesse allora, la Bibbia, diceva che sette giorni erano stati sufficienti a dare forma al mondo e a tutto ciò che lo abita, compreso l´uomo.
Per secoli e per millenni, gli esseri umani avevano continuato a costruire sulle rovine dei loro predecessori. In Europa, i borghi medievali erano sorti sulle rovine delle città romane, e le città moderne sui resti dei centri medievali. Poi giunse la rivoluzione industriale e si cominciò a scavare, per costruire ferrovie e strade, fabbriche e palazzi. Vennero così ritrovamenti imprevisti. Quando furono portate alla luce le prime ossa di dinosauri, chiaramente diverse da quelle di ogni animale conosciuto, si disse che non potevano appartenere ad animali esistiti un tempo e in seguito scomparsi, perché era impensabile che Dio avesse creato una specie vivente per poi scoprire di essersi sbagliato e portarla all´estinzione.
Sempre ragionando in questo modo, quando furono ritrovate, nel 1856, le prime ossa di uomini di Neandertal, che sono molto più spesse e robuste delle nostre, furono attribuite a grandi scimmie o a patologie dell´apparato scheletrico umano.
Ma le scoperte proseguirono, e col tempo divenne impossibile negare che il pianeta era stato abitato, in un lontano passato, da una miriade di piante e di animali parecchio diversi da quelli che abbiamo intorno oggi, e anche da uomini di aspetto profondamente diverso dal nostro. Nel frattempo, i geologi si erano resi conto, seguendo altre vie, che la Terra doveva essere immensamente più antica dei seimila anni computabili in base alla Sacra Scrittura.
Si trovarono altri testi, ben più vecchi della Bibbia. Nel ‘700 si cominciò a stimare, per il pianeta, un´età di quasi centomila anni, o maggiore ancora. Oggi parliamo di circa 4,5 miliardi di anni.
Fra il 1831 e il 1836, un giovane naturalista inglese, Charles Darwin, traversava il mondo su un brigantino della marina britannica diretto a effettuare rilievi cartografici dell´America meridionale. Nel corso del viaggio ebbe modo di osservare una molteplicità di piante e di animali: ne raccolse campioni, li analizzò e si rese conto che le stesse specie, vivendo in luoghi separati e lontani l´uno dall´altro, avevano assunto caratteri differenti, che variavano a seconda di ciò di cui si nutrivano e dell´ambiente in cui abitavano. Ne derivò l´idea che le specie viventi cambino nel corso del tempo, sviluppando caratteristiche diverse, e che sopravvivano gli individui e le popolazioni che meglio riescono a procurarsi il necessario nutrimento e a riprodursi, risultando così meglio adattate all´ambiente in cui vivono. All´opposto, gli individui e le popolazioni che hanno maggiori difficoltà a crescere e a riprodursi tenderanno a scomparire, nel volgere delle generazioni. E l´ambiente, quindi, a compiere una selezione fra le diverse specie e fra le varie popolazioni e individui di una stessa specie. Poiché l´ambiente cambia di continuo, anche le caratteristiche dei viventi cambiano, nel corso del tempo.
Darwin chiamò questo processo selezione naturale. Non era ancora chiaro come nascessero questi cambiamenti, ma si sapeva che gli agricoltori e gli allevatori di bestiame selezionavano e incrociavano fra loro le varietà più promettenti di piante e di animali, per migliorarne la produttività e altre caratteristiche, operando un processo di selezione artificiale per molti aspetti simile a quello che in natura avviene spontaneamente. In Inghilterra, i due secoli precedenti a Darwin avevano visto grandi progressi in agronomia e zootecnia.
Un altro naturalista inglese, Alfred Russell Wallace, che pure aveva lavorato a lungo in America meridionale, giungeva negli stessi anni a conclusioni analoghe a quelle di Darwin, benché, molto più giovane di lui, non le avesse sviluppate con ampiezza paragonabile. I tempi erano ormai maturi per introdurre l´idea che le specie non sono immutabili, e quando Darwin pubblicò, nel 1859, il risultato dei suoi studi, con il titolo Sull´origine delle specie per selezione naturale, l´opera andò esaurita in un giorno.
Era nata la scienza dell´evoluzione. Suscitò controversie così vivaci da non essersi ancora spente oggi.
In cosa consiste l´evoluzione? Oggi la definiamo come il cambiamento continuo ed inevitabile delle specie nel corso del tempo. E bene chiarire subito che "evoluzione" non significa necessariamente né "miglioramento" né "progresso": si sono osservati parecchi casi di regressione pura e semplice, nel corso della storia, e deviazioni che hanno dato origine a rami nuovi, in seguito scomparsi, anche in popolazioni della linea umana.
Evoluzione significa prima di tutto differenziazione progressiva. Gli esseri viventi cambiano nel corso del tempo: compaiono forme nuove che possono coesistere a lungo accanto alle più antiche e che a loro volta vanno incontro a nuovi cambiamenti.
Basti pensare alla straordinaria varietà delle piante da fiore o degli uccelli, o dei dinosauri riportati alla luce negli ultimi duecento anni. L´evoluzione comporta quindi trasformazione e un aumento della varietà disponibile, a cui si accompagna spesso, ma non sempre, un aumento di complessità. Valga ad esempio l´estrema raffinatezza raggiunta da organi quali l´occhio o l´orecchio, nell´arco di centinaia di milioni di anni, o lo sviluppo del cervello umano, che ci rende capaci di pensieri e attività sconosciute ai tempi in cui i nostri antenati non avevano ancora imparato a usare il fuoco, o a rompere con pietre le ossa di animali per succhiarne il midollo. All´opposto, molti parassiti si specializzano assai, semplificando o perdendo le parti inutili e perfezionando quelle che permettono loro di attaccarsi ai loro ospiti e di penetrarvi. Una volta entrati, li costringono a moltiplicare i parassiti, a proprio danno, e a spargerne i figli all´esterno.
Evoluzione significa, infine, sviluppo di capacità di interazione con l´ambiente. È questo, in definitiva, a decidere del successo di una specie o della sua scomparsa. I grandi uccelli senz´ali che abitavano la Nuova Guinea nella preistoria sono stati portati all´estinzione quando nel loro ambiente sono sbarcati uomini armati di lance di legno con la punta indurita al fuoco.
Alla stessa stregua, intere popolazioni umane sono scomparse quando nel loro ambiente sono penetrati bacilli, come i virus dell´influenza o del morbillo, contro cui non erano in grado di difendersi.
Cosa rende possibile l´evoluzione? La risposta semplicissima è: la vita stessa. Qual è la caratteristica principale della vita?
Non è il movimento: le piante sono vive ma non si muovono. Non è la complessità: un´auto è complessa e si muove, ma non è viva. Non è nemmeno la capacità di nascere, crescere e morire: anche una roccia "nasce", per esempio in un´eruzione vulcanica; un cristallo può crescere; e ogni cosa prima o poi ha fine. La caratteristica esclusiva della vita è l´autoriproduzione: la vita riproduce se stessa, se trova condizioni adeguate, e può assumere una enorme varietà di forme, come testimonia il mondo che abbiamo intorno. Anche un cristallo può formare copie di se stesso, in condizioni opportune, ma tutte avranno struttura identica al genitore. Un batterio ha struttura identica al genitore, ma nel corso delle generazioni può cambiare, e pur mostrando una complessità che nel cristallo non esiste continua a riprodursi quasi identico a se stesso, e simultaneamente ad evolvere.
Lo studio della vita ha fatto passi da gigante dai tempi di Darwin, e le ragioni e i modi del cambiamento oggi sono ampiamente noti. Ne parleremo nei prossimi articoli, perché si tratta degli eventi che rappresentano il motore stesso dell´evoluzione. Non sappiamo ancora come la vita abbia avuto origine, né se sia sorta sulla Terra o sia venuta dallo spazio su di un meteorite. Se è sorta sulla Terra, deve esserci voluto parecchio tempo perché potesse comparire, perché la nascita della vita deve essere un evento estremamente raro. Questo non significa che sia apparsa solo qui: vuole solo dire che c´è stato un luogo e un momento in cui una stringa di molecole è riuscita ad agganciare alcuni atomi, alcuni pezzi da costruzione, nell´ambiente circostante, e ad organizzarli intorno a sé in modo da formare una copia esatta, una sorta di carta carbone, di se stessa.
C´è una riflessione che potrà disturbare chi non accetta che la vita possa avere davvero avuto origine da sola, ma vuole che sia sorta per un intervento esterno, extraterrestre, e che non abbia trovato da sé la sua strada, ma si sia sviluppata seguendo un piano preordinato, magari addirittura in vista di un finale già scritto. È una semplice considerazione: se davvero la vita «ha fatto tutto da sola», cosa che non è dimostrata e forse non è nemmeno dimostrabile, ma è perfettamente compatibile con ciò che sappiamo, allora non si sa dove stiamo andando, non si sa cosa potremo diventare, nessun piano guida la storia della vita, e ciò che sarà dell´umanità e del pianeta su cui si è imposta come specie dominante dipende in larga misura dalle scelte che faremo. Portiamo con noi nella vita, insomma, piena responsabilità per ciò che siamo e per ciò che diventeremo.
Questa incertezza disturba il senso di sicurezza di molti, e li spinge a cercare una figura paterna che insegni e diriga, e dicendo loro dove andare li sottragga a questa responsabilità. Ha fondamento questa aspirazione ad essere guidati? Nessuno può dimostrarlo, anche se molte menti eccelse ci hanno provato.
Ciascuno deve scegliere a cosa prestare fede al riguardo, ma negare che vi sia evoluzione significa rinunciare alla nostra capacità di ragionamento, e a tutto quanto sappiamo.
(1 - continua)
Corriere della Sera 27.6.07
La Cgil e la grande paura di farsi scavalcare dal Prc
di Enrico Marro
«Non scopriamo il fianco sinistro» La Cgil in gara con Rifondazione
Epifani si prepara a una «firma provvisoria». Poi vuole il referendum
ROMA — All'ottimismo di Romano Prodi e di Tommaso Padoa-Schioppa si è contrapposto per tutto il giorno il pessimismo della Cgil e di Rifondazione comunista. E non è stato solo per bilanciare i messaggi del presidente del Consiglio e del ministro dell'Economia, ma anche per segnalarsi l'un l'altro — il sindacato di Guglielmo Epifani e il partito di Franco Giordano — che, nel campo di battaglia delle pensioni e del lavoro, nessuno avrebbe lasciato scoperto il fronte sinistro. Giordano e il ministro della Solidarietà sociale, Paolo Ferrero, hanno cominciato dalla mattina presto a frenare rispetto a ipotesi di accordo, a ribadire che lo «scalone Maroni» non poteva semplicemente essere ammorbidito come spiegava il governo, ma che andava «abolito, come prevede il programma ». A quel punto la Cgil ha cominciato a non sentirsi più garantita rispetto agli impegni presi dalla Rifondazione solo qualche settimana fa. E a dire il vero anche la Cisl e la Uil sono diventate sospettose, anche se a loro un eventuale scavalcamento a sinistra da parte dei massimalisti creerebbe molti meno problemi.
Ma andiamo con ordine.
Un paio di settimane fa i vertici di Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato i capigruppo delle sinistre radicali (Rifondazione, Pdci, Verdi e Sinistra democratica) ottenendo da tutti la garanzia che un eventuale accordo dei sindacati col governo non sarebbe stato rimesso in discussione in Parlamento e nelle piazze. Come dire: «Quello che va bene a voi andrà bene anche a noi e non vi creeremo problemi». Poi però sono successe due cose che hanno un po' cambiato il quadro.
Prima il flop della manifestazione delle sinistre radicali a piazza del Popolo contro la visita del presidente americano Bush a Roma e secondo la candidatura di Walter Veltroni alla guida del Partito democratico. Entrambe le cose hanno rafforzato, soprattutto in Rifondazione, le posizioni più intransigenti, quelle che vogliono «recuperare il rapporto con i movimenti», «l'insediamento sociale» del partito e la sua connotazione di lotta. Posizioni che hanno fatto leva anche sul preoccupante calo di consensi registrato da Rifondazione alle elezioni amministrative. Insomma, dalle parti di Giordano è suonato più di un campanello d'allarme sul fatto che la permanenza al governo è rischiosa. Questo non significa assolutamente che Rifondazione pensi di uscire, ma che appunto vuole essere ancora di più «partito di lotta e di governo».
Queste cose in Cgil le sanno benissimo, non fosse altro perché hanno in casa un pezzo di Rifondazione. Anzi, allargando lo sguardo a tutte le sinistre radicali, almeno metà del gruppo dirigente di Corso Italia fa riferimento a formazioni che stanno alla sinistra dei Ds e domani del Partito democratico. Mezza segreteria guarda alla Sinistra democratica di Mussi e Salvi. E lì guardano anche i vertici di categorie importanti come la Funzione pubblica, la Scuola, l'Agro Industria. Per non parlare della Fiom, i metalmeccanici, che hanno in segreteria Giorgio Cremaschi, esponente della sinistra estrema di Rifondazione.
Ecco perché l'insistenza di Giordano e Ferrero per «l'abolizione» dello scalone non è passata inosservata a piani alti della Cgil. Ed è montato il sospetto che le garanzie offerte qualche settimana fa non fossero più tanto sicure. Meglio premunirsi. L'altro ieri Epifani ha tastato il polso dell'organizzazione consultando la «delegazione alla trattativa» che, tanto per dare l'idea, è composta da tutti i segretari di categoria e tutti i segretari regionali. Non solo. Per oggi alle 15 è convocato il direttivo, cioè il parlamentino della Cgil, che siederà praticamente in seduta permanente per valutare l'accordo. Epifani, insomma, vuole garantirsi il più possibile all'interno. E comunque, in uno degli ultimi incontri a Palazzo Chigi, ha annunciato al governo che la Cgil rispetto a un'eventuale intesa metterà per il momento una sigla provvisoria, in attesa del referendum dei lavoratori. Solo dopo il loro sì, Epifani firmerà l'intesa. Ed è proprio il referendum la soluzione che, come nel '95, dovrebbe consentire alla Cgil di confermare l'accordo (a maggioranza) e evitare che il no dei metalmeccanici (ci fu già sulla riforma Dini) e di altri pezzi della confederazione metta in discussione gli equilibri interni. Lo stesso referendum al quale potrebbero appellarsi Giordano per contenere i dissensi nel partito. Ma ieri sera Epifani ha chiesto anche un'ultima garanzia. Direttamente a Prodi: che l'accordo venga blindato con un decreto o con un disegno di legge sul quale porre la questione di fiducia. E impedire quindi ogni rilancio di Rifondazione.
l'Unità 27.6.07
Meneghello, un’altra lingua un’altra Resistenza
di Stefano Guerriero
È MORTO IERI, a 85 anni, lo scrittore vicentino, autore negli anni 60 di Libera nos a malo e I piccoli maestri. Lo scavo nel dialetto, la «leggerezza» calviniana e la condizione di outsider caratterizzano la sua opera e la sua testimonianza sul biennio 43-45
Delle qualità che Calvino proponeva per il millennio che ormai stiamo vivendo, Luigi Meneghello aveva indubbiamente in modo cospicuo la leggerezza. Una leggerezza acuta e divertita che tuttavia non presuppone disimpegno o distacco dalla realtà: tutt’altro.
Questa leggerezza in anticipo sui tempi è uno dei due motivi per cui si è tardato forse fino alla metà degli anni Ottanta a riconoscere il suo valore, nonostante avesse esordito con due libri innovativi di grande portata: Libera nos a malo (Feltrinelli 1963), romanzo, o non romanzo che sia, linguistico e sociologico sulla propria infanzia e sul mutamento della società contadina e del suo dialetto, e I piccoli maestri (Feltrinelli 1964), la più celebre narrazione resistenziale, anch’essa a sfondo autobiografico. L’altro motivo della tardiva scoperta è la sua qualità di outsider: Meneghello ha insegnato letteratura italiana in Inghilterra all’Università di Reading dal 1947 e questo faceva di lui forse un provinciale, un marginale agli occhi dell’establishment letterario italiano. Ma la distanza certo non gli ha nuociuto: la sua scrittura muove da una lontananza nello spazio e nel tempo; è animata da un ripensamento (degli anni della guerra e del Ventennio fascista) che non diventa malinconica letteratura del ricordo ma lucida volontà di comprendere e anche di denunciare i propri e altrui errori, sia pure evocati con affetto. Sta di fatto che nel ’63 a parte i recensori d’ufficio pochi leggono Libera nos a malo, che pure era al passo con il clima neoavanguardistico, per il suo essere tutto giocato sullo «sfasamento tra il mondo delle parole e quello delle cose»; per il suo scavo nel dialetto che come le lingue specifiche degli occhi e di altri sensi, «è sempre incavicchiato alla realtà, per la ragione che è la cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare». Anche I piccoli maestri, singolarmente scritto nell’anno di morte di Fenoglio, l’altro grande cantore non ideologico della Resistenza, si afferma a fatica, con una prima riedizione, drasticamente riveduta dall’autore, nel ’76 e via via altre edizioni tra cui una scolastica nell’88.
I piccoli maestri inizia genialmente con l’atto di viltà più grave per un combattente: l’abbandono dell’arma, un parabellum lasciato in una crepa nella roccia durante un rastrellamento. E perché non ci siano dubbi l’autore mette subito in chiaro che a quei tempi di armi ne perdevano di continuo che in realtà «non eravamo mica buoni, a fare la guerra». È un libro tutto scritto in chiave antieroica, tutto contro la vulgata resistenziale e insieme tutto a favore delle ragioni della Resistenza, nonostante gli errori materiali e ideali che pure Meneghello vi riconosce. Un libro anticonformista. Si svolge tra l’Altipiano di Asiago e il Veneto, dove ha operato la singolare brigata del piccolo maestro Toni Giuriolo negli anni della guerra civile (guerra civile è un termine che ritorna di continuo nella narrazione: Meneghello non ha paura delle parole). Nelle vicende di questa pattuglia di «deviazionisti crociani di sinistra», come li definisce ironicamente l’autore, c’è la paura e il fascino della morte violenta, l’eccitazione dei rastrellamenti, ma anche le azioni fallite, il tragico spararsi addosso per errore: fatti dopo i quali «uno si sentiva soldato, frate, fibra dell’universo, e mona». Il piglio antiretorico è sistematico e coinvolge tutti i miti giovanili, compresi i miti culturali. All’eroismo viene preferito l’empirismo: «l’eroismo è più bello, ma ha un difetto, che non è veramente una forma della vita. L’empirismo è una serie di sbagli, e più sbagli e più senti che stai crescendo, che vivi». Un empirismo che è una differenza sostanziale con l’eroismo mortuario delle milizie di Salò. Contemporaneamente c’è la sincera e difficile rievocazione dell’entusiasmo giovanile, della fascinazione dell’avventura che si concretizza ad esempio nell’adorazione delle armi, odiate perché poche, brutte e vecchie, ma comunque sacre.
La compresenza dello sguardo del giovane di allora e dell’uomo maturo degli anni sessanta, entrambi rivolti sull’oggetto Resistenza, senza che l’uno falsifichi l’altro, è l’elemento più mirabile dei Piccoli maestri. Tutto è tenuto insieme con un’abilissima ironia, insieme lucida e affettuosa. La stessa ironia che caratterizza tutti i libri di Meneghello, da Fiori italiani (Rizzoli 1976) sull’educazione in tempo di fascismo e oltre, a Bau-sète (Rizzoli 1988), gustosa rievocazione del dopoguerra e della sua attività per il Partito d’Azione, il partito perfetto «per cui non votarono neanche le nostre fidanzate», fino alle ricerche linguistiche di Jura (Garzanti 1987) e oltre.
Meneghello è ormai consacrato come un classico, un fatto testimoniato dai volumi Rizzoli delle Opere e dal fiorire di edizioni, che certo come sempre in questi casi aumenterà ancora. È auspicabile che questo fiorire favorisca una ricezione ampia e completa dell’autore. Attualmente si ha l’impressione che sia un po’ la primizia sulla quale il critico-linguista sperimenta le proprie ricette. Certo i linguisti, da Giulio Lepschy a Cesare Segre a Maria Corti, hanno il merito indiscusso di aver difeso questo autore quando pochi lo conoscevano veramente. La sperimentazione linguistica, il lavoro di ricerca sulla lingua e sul dialetto, le contaminazioni con l’inglese sono dati imprescindibili per la comprensione del valore formale della sua scrittura.
Tuttavia è vero che in Meneghello c’è un fondo di passione e di volontà di comprendere che lo rendono anche un testimone eccezionale e sostanzialmente inedito dei decenni più difficili della storia italiana e della Liberazione. Insieme a Fenoglio, al Calvino del Sentiero dei nidi di ragno e, perché no, a Tiro al piccione di Giose Rimanelli, Meneghello può essere la via di accesso privilegiata alla comprensione di che cosa è stata veramente la Resistenza e la guerra civile. Sono argomenti che meritano attenzione al di fuori della cerchia degli specialisti.
il Riformista 26.6.07
Nigeria, il dramma dei bimbi-cavia
di Paolo Soldini
È il 1996. In Nigeria si diffonde un'epidemia di meningite che provoca, in poche settimane, 15mila morti, soprattutto bambini. II governo di Abuja chiede aiuto all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e alle industrie farmaceutiche internazionali. Una risponde: la Pflzer, l'azienda americana famosa per il Viagra. Un team di medici inviati da New York si mette al lavoro in uno degli ospedali da campo in cui vengono accolti i piccoli malati. Hanno un farmaco nuovo, si chiama Trovan, appena prodotto dai laboratori della Pfizer. Nell'ospedale c'è anche un'équipe di Medici senza frontiere (Msf), ma né a loro né ai genitori dei bambini né a chiunque altro viene chiesto se sia il caso o no di testare il farmaco su 200 piccoli malati. I medici del team americano avrebbero anche nascosto ai familiari il fatto che nello stesso ospedale i bambini potevano essere curati con gli antibiotici di cui gli operatori di Msf erano abbondantemente fomiti.
Insomma: duecento cavie umane, trattate come cavie e basta in nome del profitto. Duecento bambini usati come oggetti senza valore per scoprire che la medicina non funziona e, soprattutto, che ha effetti collaterali micidiali. Dei 200 piccoli malati, infatti, I11 muoiono, molti restano paralizzati, molti perdono la vista, altri l'udito. Tutti, senza eccezioni, soffrono conseguenze gravi.
Oggi sulla vicenda, che ricorda in modo impressionante la trama dell'ultimo romanzo di John Le Carré The Constant Gardercer (e del film che ne è stato tratto), ad Abuja comincia un processo che potrebbe fare storia. II governo nigeriano, dopo aver a lungo esitato di fronte alle richieste disperate dei genitori delle piccole vittime, si decide a chiedere alla Pfizer un risarcimento di 7 miliardi di dollari. L'entità della richiesta è motivata anche da un "effetto collaterale" che nessuno avrebbe mai potuto prevedere: nel nord del Paese, dominato dai clan musulmani, dopo lo scoppio dello scandalo si è diffusa la fobia delle medicine fornite "dagli occidentali", i quali, secondo i fanatici islamici, starebbero operando una vera e propria sterilizzazione di massa per cancellare dal Paese tutti i seguaci di Allah. Molti ambulatori sono stati distrutti e nella regione viene boicottata violentemente la distribuzione di ogni vaccino che venga dall'estero. La conseguenza è che, secondo l'Oms, la poliomielite e altre malattie infettive starebbero infuriando di nuovo in zone da cui erano state sradicate.
La Pfizer si difende sostenendo che non si può affermare con certezza che la trovafexocina, il principio attivo del Trovan, sia stato l'effettiva causa delle morti e delle gravissime menomazioni. Ma a smentirli c'è, oltre al modo clandestino con cui il farmaco veniva somministrato, un preciso warming lanciato nel '99 dalla Food and drug amministration (Fda). Secondo l'ente federale statunitense, l'uso del Trovan, che non è mai stato approvato per il trattamento della meningite, è "legato a tossicità epatica e mortalità". L'elenco delle controindicazioni pubblicato dal British Medical Journal (Bmj) d'altra parte riempie pagine e pagine: ci sono scritti tutti i motivi per cui quella medicina non avrebbe mai dovuto essere somministrata a 200 poveri innocenti.
martedì 26 giugno 2007
Altre immagini di Piazza della Minerva, a Roma
Domenica pomeriggio 24 giugno 2007


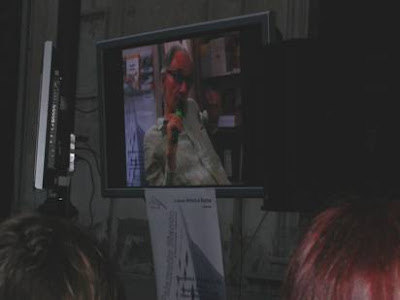
In libreria potete trovare:
alcune tra le principali riviste che hanno pubblicato articoli sul Palazzetto Bianco:
D’architettura n.32(aprile 2007)
L’Arca n.218 (ottobre 2006)
Metamorfosi n. 60 (maggio/giugno) 2006
***
I volumi delle Nuove Edizioni Romane citati durante il dibattito:
Il Coraggio delle Immagini.
Progetti realizzati da un gruppo di architetti italiani su idee e disegni di Massimo Fagioli (1986-1995)
L’Architettura e la morte dell’arte.
atti del convegno “ L’Architettura e la morte dell’arte. Un secolo di crisi” svoltosi il 26 e 27 Gennaio 1996al teatro Eliseo di Roma
e
Immagine della linea
Atti del convegno tenutosi al Palazzo dei Congressi di Firenze il 26 Ottobre 1996
in occasione dell’apertura della mostra di architettura ‘Il Coraggio delle Immagini’
***
 ‘Comporre l’architettura’
‘Comporre l’architettura’
di Franco Purini
(Laterza 2006)
Comporre architetture significa gestire un sistema complesso di variabili funzionali, simboliche, rappresentative e produttive. Dato il suo carattere composito, non è possibile parlare di regole per la composizione. Si potrebbe parlare piuttosto di scelte, ma è meglio parlare di idee-strumento a metà tra il concettuale e l'operativo, tra teoria e pratica. Questo libro affronta tutte le questioni legate all'essercizio compositivo: dai vincoli funzionali di un edificio alle intenzioni formali di chi progetta, dalle richieste della committenza al rispetto degli ordinamenti legislativi.

(foto di Lorenzo Fagioli)
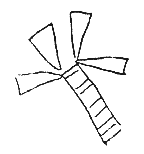 Libreria Amore e Psiche
Libreria Amore e Psiche
via s. caterina da siena, 61 Roma
(piazza della Minerva, Pantheon)
info:06/6783908 libreria@amorepsiche.it
i nostri orari: lunedi 15-20
dal martedi alla domenica 10-20
www.amorepsiche.it
Domenica pomeriggio 24 giugno 2007


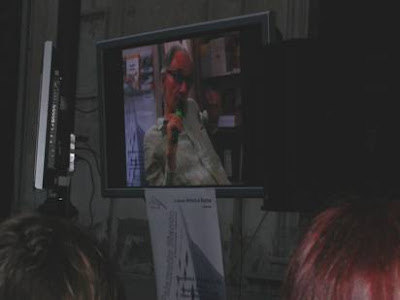
In libreria potete trovare:
alcune tra le principali riviste che hanno pubblicato articoli sul Palazzetto Bianco:
D’architettura n.32(aprile 2007)
L’Arca n.218 (ottobre 2006)
Metamorfosi n. 60 (maggio/giugno) 2006
***
I volumi delle Nuove Edizioni Romane citati durante il dibattito:
Il Coraggio delle Immagini.
Progetti realizzati da un gruppo di architetti italiani su idee e disegni di Massimo Fagioli (1986-1995)
L’Architettura e la morte dell’arte.
atti del convegno “ L’Architettura e la morte dell’arte. Un secolo di crisi” svoltosi il 26 e 27 Gennaio 1996al teatro Eliseo di Roma
e
Immagine della linea
Atti del convegno tenutosi al Palazzo dei Congressi di Firenze il 26 Ottobre 1996
in occasione dell’apertura della mostra di architettura ‘Il Coraggio delle Immagini’
***
 ‘Comporre l’architettura’
‘Comporre l’architettura’di Franco Purini
(Laterza 2006)
Comporre architetture significa gestire un sistema complesso di variabili funzionali, simboliche, rappresentative e produttive. Dato il suo carattere composito, non è possibile parlare di regole per la composizione. Si potrebbe parlare piuttosto di scelte, ma è meglio parlare di idee-strumento a metà tra il concettuale e l'operativo, tra teoria e pratica. Questo libro affronta tutte le questioni legate all'essercizio compositivo: dai vincoli funzionali di un edificio alle intenzioni formali di chi progetta, dalle richieste della committenza al rispetto degli ordinamenti legislativi.

(foto di Lorenzo Fagioli)
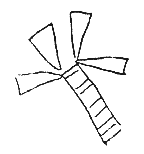 Libreria Amore e Psiche
Libreria Amore e Psichevia s. caterina da siena, 61 Roma
(piazza della Minerva, Pantheon)
info:06/6783908 libreria@amorepsiche.it
i nostri orari: lunedi 15-20
dal martedi alla domenica 10-20
www.amorepsiche.it