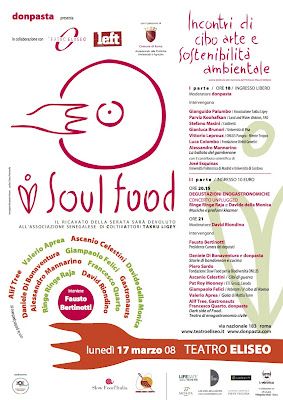Nazismo, l’onda di ritorno in Germania
di Paolo Soldini
Datemi delle persone mediamente acculturate, come ad esempio una classe di studenti di liceo, una realtà istituzionale fortemente strutturata, diciamo una scuola, e una personalità dotata di un certo carisma come può essere un bravo e stimato insegnante e in una settimana vi creo il nazismo in laboratorio. È la tesi, anzi: la trama, di «Die Welle» (L’onda), un film che esce in questi giorni in Germania. Il regista Dennis Gansel ne ha fatto un’opera di fantasia, con una conclusione tragica e simbolicamente pedagogica: la classe di «nazisti artificiali», trasformatasi in setta assassina, viene sterminata.
Ma la storia è avvenuta davvero, con una conclusione meno truculenta ed è raccontata in un libro dell’americano Morton Rhues che è un classico della letteratura pedagogica e viene letto nelle scuole statunitensi nell’ambito dei programmi di storia ed educazione civica, così come viene proiettato un documentario che ne venne tratto. Rhues, che negli anni 60 insegnava in una scuola superiore di Palo Alto (California), per convincere gli studenti di una nona classe del fatto che sbagliavano a pensare che un’esperienza autoritaria tipo il nazismo fosse «inconcepibile» in una società libera come quella americana, organizzò un singolare esperimento: chiese ai ragazzi di adottare certi riti sociali (come il saluto con il braccio destro che mima il movimento di un’onda) e certe uniformità di comportamento in fatto di linguaggio e gerarchie. Poi ordinò di isolare e di punire chi si rifiutava. Nel giro di qualche giorno la classe si era trasformata in una piccola società di gregari pronti a tutto. Quando, un giorno, Rhues si accorse che persino il preside lo salutava con «l’onda», ebbe paura di essere andato troppo in là e interruppe bruscamente l’esperimento (nel film di Gansel ambientato in Germania l’insegnante, Rainer Wenger, non ci riesce e i giovani precipitano nella tragedia).
Ancor prima di uscire, «Die Welle» ha sollevato un’infinità di discussioni e di polemiche che ruotano, in larga parte, sullo stesso pre-giudizio che fu alla base dell’esperimento di Palo Alto: da noi, nella Germania democratica, liberale e fin troppo individualista in cui crescono i giovani del 2000, «non potrebbe mai succedere». Si parla molto, ma è bizzarro come a nessuno (per quanto ne sappiamo noi) sia venuto in mente di notare che la discussione su «Die Welle» è straordinariamente simile a quella che scosse il paese dodici anni fa, quando uscì «Hitlers willige Vollstrecker», l’edizione tedesca di «Hitler’s Willing Executioners» in cui lo storico americano Daniel Jonah Goldhagen sosteneva una tesi che è, a ben vedere, una sorta di trasposizione in grande delle tesi alla base dell’esperimento di Palo Alto: invece della classe, l’intera nazione tedesca; al posto della scuola, lo Stato e, come figura carismatica, non uno stimato professore ma un diabolico demagogo privo di scrupoli. La «follia» nazista, agli occhi di Goldhagen, non deriva né dalla corruzione né dalla devianza di una parte della società tedesca, ma le è, per così dire, connaturale. Una volta data l’esistenza delle tre condizioni - identità comunitaria, organizzazione politica dello Stato, dittatore in grado di esprimere un «Führerprinzip» - il nazismo viene «da solo» e porta con sé il suo frutto più disperatamente perverso: l’esclusione e l’odio per gli altri, i «diversi», i «non tedeschi», i «non ariani», i «deviati». Esclusione e odio che traggono elemento dall’antisemitismo diffuso nella società della Germania come in quella di tutta Europa, ma solo in Germania sfociano in un universo criminale di annientamento degli ebrei cui - questo è l’aspetto più duro e controverso delle tesi che Goldhagen argomenta con indubbia efficacia nel suo libro - partecipa consapevolmente e con entusiamo l’intera società tedesca.
Forse non è tanto strano che la discussione sui temi evocati da Goldhagen non sia stata rievocata nel momento in cui si attende l’uscita di «Die Welle». Su quei temi ha operato, da subito (e per anni) un meccanismo di rimozione che, insieme con certi aspetti molto forti dell’opera dello storico americano, figlio di un ebreo di Czernowitz sopravvissuto all’Olocausto, ha teso a seppellire molti lavori scientifici sul rapporto della «normale» società tedesca con la Shoah usciti in Germania a metà degli anni 90: dal celebre «Ordinary Men, the Reserve Police Battaillon 101» di Cristopher Browning sulla partecipazione entusiastica di pacifici e miti pensionati della polizia di Amburgo agli orribili eccidi degli Einsatzgruppen nei Paesi Baltici, in Bielorussa e in Ucraina, agli studi di Louis Begley, Elie Wiesel, Götz Aly e tanti altri. Nel dibattito è stato evocato, invece, Jonathan Littell con il suo «Les Bienveillantes», il romanzo di stile biografico che è stato il caso letterario dei mesi scorsi e che, dopo molte esitazioni, sta per uscire anche in tedesco presentandosi un po’ come l’altra faccia della medaglia dei Vollstrecker di Goldhagen: tutti i tedeschi hanno, a loro modo, partecipato, sostiene il secondo; chiunque, messo nelle condizioni di Max Aue, l’ufficiale delle SS protagonista de «Le benevole», avrebbe potuto, secondo il primo, compiere gli stessi crimini considerandoli espressione del proprio ruolo e del proprio dovere verso lo Stato. Tutte e due le posizioni confinano in modo assai significativo, come si vede facilmente, con le scelte della classe di «Die Welle». Non è un caso neppure, allora, che il dibattito sul film sia andato ad arenarsi su un punto che è importante ma, in fin dei conti, non è il più importante e che, soprattutto, aggiunge poco a una discussione che data dalla fine della seconda guerra mondiale e, almeno, dal Processo di Norimberga: quanto sapevano e quanto potevano non sapere i tedeschi «normali» della Shoah e dei crimini nazisti? Domanda oziosa quant’altre poche alle orecchie di chiunque abbia avuto un minimo di frequentazione con i luoghi dell’Olocausto o abbia un minimo di conoscenza, anche indiretta, dei rapporti che si creano tra il fronte e la madrepatria nei periodi bellici. Il Lager di Buchenwald funzionò per otto anni, producendo almeno 30 mila morti, nella foresta di Etterberg, che domina Weimar, la capitale della omonima Repubblica e della Germania letteraria e artistica tra le due guerre. È impensabile che i 100mila e più abitanti della città e dei dintorni non si siano accorti di quanto accadeva nei boschi in cui, normalmente andavano a passeggiare e organizzavano picnic. Un altro dato: alla campagna contro l’Unione Sovietica parteciparono diverse centinaia di migliaia di soldati della Wehrmacht, che furono tutti testimoni delle uccisioni di massa degli ebrei nei territori occupati. Dal fronte i militari potevano scrivere liberamente a casa e lo facevano: quanti milioni di testimonianze raggiunsero la Germania solo per questa via?
Che i tedeschi non potessero non sapere è un dato storicamente acquisito. Le riflessioni su «Die Welle» dovrebbero fissarsi intorno a un altro dato. Quello originario, che motivò l’esperimento di Rhues, l’idea che «qui da noi in America non potrebbe succedere» e la sua versione europea anni Duemila: «Oggi qui da noi non potrebbe succedere». Ma ad Abu Ghraib e a Falluja c’erano dei soldati americani, dal massacro, «tutto europeo», di Srebrenica sono passati solo tredici anni e per le strade di Berlino, di Parigi e di Roma ricompaiono svastiche e croci celtiche, e si «sdoganano» fascisti e nazisti. «Da noi non succede»: ne siamo così sicuri?
l'Unità 17.3.08
Bertinotti: la sinistra forte è utile anche al Pd
Il candidato premier in comizio a Rieti: ricordiamoci che il governo Prodi è caduto a destra
Il presidente della Camera: i democratici guardano al centro, non parlano delle crisi del Paese
Fausto Bertinotti si prepara a fare opposizione, che a vincere le elezioni sia il Pd o il Pdl. Ma proprio per questo, dice, il «voto utile» per chi vuole difendere gli interessi dei lavoratori è quello per la Sinistra arcobaleno. «Veltroni dice di essere un riformista e non di sinistra, ed è vero - dice Bertinotti nel corso di un comizio a Rieti - e il Pd è una formazione di centrosinistra che guarda al centro. Ogni singolo voto per la Sinistra arcobaleno è un modo di “costringere” il Partito democratico a guardare a sinistra. Se saremo tanti, se saremo massa critica, allora il Pd dovrà guardare a sinistra». Bertinotti non è tenero con la forza guidata da Veltroni. Quel partito, dice, non parla di crisi e avanza proposte vicine a quelle delle destre. L’errore di fondo è che il Pd accetta questo modello di sviluppo che ritiene di poter correggere: «È come cercare di svuotare il mare con un secchiello». A prova di ciò Bertinotti cita l’inserimento nelle liste del Pd di Calearo, «il falco della Federmeccanica che ha costretto i metalmeccanici, che hanno le retribuzioni basse che conosciamo, a cinquanta ore di sciopero, a togliersi cioè dalla busta paga il valore retributivo di cinquanta ore di sciopero. Questo dimostra di non aver capito qual è la situazione italiana».
Circa il governo uscente, Bertinotti confessa di non avere nessuna «nostalgia di Prodi», che ha fatto bene alcune cose, come la politica estera, ma ha «sbagliato tutto sulla precarietà»: «Ha fallito essenzialmente nel non aver portato avanti una chiara discontinuità con il governo Berlusconi, nell’aver lasciato sostanzialmente in atto la legge in vigore», dice aggiungendo che «per guadagnare una capacità di intervento bisogna superare la legge 30». Il candidato premier della Sinistra arcobaleno ci tiene a sottolineare che Prodi «è caduto da destra», ma ricorda anche che «la critica della sinistra è iniziata proprio con la discussione della riforma delle pensioni»: «L’accordo con le parti sociali era bruttino, ma la parte sul mercato del lavoro era brutta e basta».
l'Unità 17.3.08
Nel diario esistenziale di Anders, «Discesa nell’Ade. Auschwitz e Breslavia, 1966», un lungo ma deludente viaggio nei luoghi d’origine
La nostra specie? È senza speranza... Scompariremo come le vittime della Shoah
di Igino Domanin
L’approdo tardivo a una terra natale, spogliata ormai delle sue valenze affettive, devastata e senza radici, dove non ha più senso immaginare una patria. Questo è il senso delle amarissime considerazioni che costellano il fitto diario esistenziale di Anders, Discesa nell’Ade. Auschwitz e Breslavia, 1966 pubblicato per i tipi di Bollati Boringhieri a cura di Sergio Fabian, un drammatico reportage, una specie di libro di viaggio nei luoghi d’origine che si rivela però essere la narrazione di una catabasi negli Inferi.
Anders scrive una filosofia d’occasione e non accademica. Non troviamo trattazioni tecniche di problemi metafisici, bensì meditazioni che prendono lo spunto da situazioni concrete. Il filo conduttore è solo l’esperienza quotidiana. Ma non si tratta di un esercizio di saggezza. Non sono aforismi che riguardano la buona vita. Al contrario, Anders, come del resto in tutti i suoi testi ci descrive l’orrore che sordamente si cela dietro le apparenze confortevoli della civiltà tecnologicamente avanzata. Questo volume, però, è particolarmente significativo dei risvolti biografici di Anders ed entra, anche con crudeltà, nelle pieghe più personali del suo pensiero.
Anders, intellettuale ebreo di nazionalità tedesca, esule in America e sopravvissuto allo sterminio degli ebrei, ritorna nella nativa Breslavia. La città ha cambiato nome, è diventata Wroclaw e adesso fa parte della Polonia comunista. Per recarvisi è necessario transitare nei pressi di Auschwitz. Il racconto del libro si apre lì. Anders e la sua terza moglie Charlotte sono in viaggio con la loro auto. Nelle vicinanze del lager. Le vittime della Shoah sono scomparse senza lasciare una traccia del loro morire. Proprio per questo, per via della loro eliminazione affidata a un cieco dispositivo tecnologico, per essere state private di qualsiasi connotazione umana della morte, non è possibile nessuna elaborazione del lutto. Un atmosfera mefitica, un miasma insopportabile si respira nell’aria. La presenza dei morti è invadente, pressante, ingombrante. Chi è sopravvissuto è soverchiato da un’incontenibile vergogna d’esistere. Un fatto che non riguarda solo il mondo ebraico, ma che diventa il crisma universale della situazione storica attuale. Per Anders, infatti, questa è diventata la condizione normale degli esseri umani. Come testimonia il prosieguo del testo, dove, a partire dall’arrivo a Breslavia, si assiste alla descrizione di uno scenario perturbante: l’assoluta mancanza di patria del mondo attuale. Siamo tutti meramente dei sopravvissuti. O dei profughi, solo per il momento scampati a un pericolo supremo. Potremmo sparire dal mondo senza nessun motivo, privati persino di poter depositare qualche segno ascrivibile alla nostra presenza. La nostra specie è senza speranza. Ha costruito sistemi di distruzione, che, se si sono rivelati micidialmente nell’epoca dei totalitarismo, sono definitivamente presenti nel nostro orizzonte. La possibilità della definitiva scomparsa del genere umano è diventa una realtà. Questo potere di distruzione senza limiti è dovuto alla tecnologia che è in grado di annichilire, fino alle estreme conseguenze, la vita. Le conseguenze attuali sono sotto il nostro sguardo. La violenza della seconda guerra mondiale non è un ricordo. Torna a ripetersi. Ma il nostro senso d’umanità pare ridursi. La stato d’eccezione diventa normale.
Per Anders il pericolo cresce smisuratamente nella misura in cui questa situazione angosciosa e solo presentita, ma non può essere immaginata. La nostra sensibilità è dimidiata. Le catastrofi ci vedono solo spettatori anestetizzati ed eticamente indifferenti. La tragedia del mondo ci appare in uno specchio irreale rispetto al quale non siamo in grado d’essere coinvolti. Siamo intrappolati dentro una deficienza emotiva, incapaci di avvertire sensibilmente la tragedia in cui siamo calati.
Questo è l’enigma che ci consegna questo preziosissimo libro. Come espandere la nostra coscienza, come dilatare il nostro mondo psichico fino a entrare in contatto con la minaccia irrapresentabile che aggredisce le fondamenta della condizione umana?
l'Unità 17.3.08
Uno studio italiano sul Dna mitocondriale retrodata il primo passaggio dello stretto di Bering
La conquista dell’America avvenne 20mila anni fa
Le prime popolazioni umane giunsero in America dall’Asia attraverso lo Stretto di Bering: su questo concorda ormai quasi tutta la comunità scientifica. Più controversa è l’epoca in cui avvenne tale colonizzazione. Fino a qualche tempo fa le teorie più accreditate fissavano la prima migrazione all’incirca 13.500 anni fa, assegnando al complesso Clovis del New Mexico (vecchio di 11.000 anni) la palma della più antica cultura originaria. Una serie di nuove scoperte archeologiche ha rimesso tutto in discussione. Ad esempio il sito preistorico di Monte Verde, in Cile, risale a 12.500 anni fa: dunque non solo è precedente a Clovis, ma impone di rivedere anche la data dell’arrivo di popolazioni umane in America: riesce difficile immaginare che i primi coloni si siano spinti, in un millennio, fino all’estremità meridionale del continente.
Ora un gruppo internazionale di ricerca diretto da due genetisti italiani, il professor Antonio Torroni dell’Università di Pavia e il dottor Alessandro Achilli dell’Università di Perugia, apporta nuovi dati al dibattito. Gli studiosi hanno esaminato il Dna mitocondriale di oltre 200 nativi, spostando a 20.000 anni fa il fatidico passaggio attraverso lo Stretto di Bering.
Il piccolo Dna mitocondriale (37 geni in tutto), trasmesso solo dalla madre e caratterizzato da un elevato tasso evolutivo, è una sorta di archivio molecolare: su di esso è registrata la storia genetica dei nostri antenati femminili. Nel caso in questione, più del 95% dei genomi mitocondriali degli indiani d’America appartiene a quattro aplogruppi (linee materne), identificati una quindicina di anni fa proprio dal professor Torroni e definiti pan-americani per la loro diffusione sull’intero continente.
Secondo i risultati della ricerca, pubblicati il 12 marzo sulla rivista scientifica PLoS one, i quattro aplogruppi pan-americani (e di conseguenza la quasi totalità della popolazione nativa) hanno un’origine genetica comune, risalente a 20.000 anni fa.
Quell’epoca segnerebbe quindi l’inizio della colonizzazione del Nuovo Mondo. Il pianeta aveva appena superato l’ultimo picco glaciale quando un gruppo umano proveniente dall’Asia si affacciò per la prima volta su un territorio inesplorato.
Repubblica 17.3.08
La verità sulle violenze al G8 di Genova
Le torture a Bolzaneto e la notte della democrazia
di Giuseppe D'Avanzo
Genova: senza il reato di tortura, pene lievi e prescritte per gli imputati
C´era anche un carabiniere "buono", quel giorno. Molti "prigionieri" lo ricordano. «Giovanissimo». Più o meno ventenne, forse «di leva». Altri l´hanno in mente con qualche anno in più. In tre giorni di «sospensione dei diritti umani», ci sono stati dunque al più due uomini compassionevoli a Bolzaneto, tra decine e decine di poliziotti, carabinieri, guardie di custodia, poliziotti carcerari, generali, ufficiali, vicequestori, medici e infermieri dell´amministrazione penitenziaria. Appena poteva, il carabiniere "buono" diceva ai "prigionieri" di abbassare le braccia, di levare la faccia dal muro, di sedersi. Distribuiva la bottiglia dell´acqua, se ne aveva una a disposizione. Il ristoro durava qualche minuto. Il primo ufficiale di passaggio sgridava con durezza il carabiniere tontolone e di buon cuore, e la tortura dei prigionieri riprendeva. Tortura. Non è una formula impropria o sovrattono. Due anni di processo a Genova hanno documentato – contro i 45 imputati – che cosa è accaduto a Bolzaneto, nella caserma Nino Bixio del reparto mobile della polizia di Stato nei giorni del G8, tra venerdì 20 e domenica 22 luglio 2001, a 55 "fermati" e 252 arrestati. Uomini e donne. Vecchi e giovani. Ragazzi e ragazze. Un minorenne. Di ogni nazionalità e occupazione; spagnoli, greci, francesi, tedeschi, svizzeri, inglesi, neozelandesi, tre statunitensi, un lituano.
Oggi la caserma non è più quella di allora: e i "luoghi della vergogna" sono stati cancellati
Manganellate, minacce, insulti, botte e umiliazioni: tutto ricostruito al processo da più di trecento testimoni Episodi documenti, provati
In quei tre giorni poliziotti e carabinieri rinchiusero per ore studenti, operai e professionisti.
Studenti soprattutto e disoccupati, impiegati, operai, ma anche professionisti di ogni genere (un avvocato, un giornalista…). I pubblici ministeri Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Miniati hanno detto, nella loro requisitoria, che «soltanto un criterio prudenziale» impedisce di parlare di tortura. Certo, «alla tortura si è andato molto vicini», ma l´accusa si è dovuta dichiarare impotente a tradurre in reato e pena le responsabilità che hanno documentato con la testimonianza delle 326 persone ascoltate in aula.
Il reato di tortura in Italia non c´è, non esiste. Il Parlamento non ha trovato mai il tempo - né avvertito il dovere in venti anni - di adeguare il nostro codice al diritto internazionale dei diritti umani, alla Convenzione dell´Onu contro la tortura, ratificata dal nostro Paese nel 1988. Esistono soltanto reatucci d´uso corrente da gettare in faccia agli imputati: l´abuso di ufficio, l´abuso di autorità contro arrestati o detenuti, la violenza privata. Pene dai sei mesi ai tre anni che ricadono nell´indulto (nessuna detenzione, quindi) e colpe che, tra dieci mesi (gennaio 2009), saranno prescritte (i tempi della prescrizione sono determinati con la pena prevista dal reato).
Come una goccia sul vetro, penosamente, le violenze di Bolzaneto scivoleranno via con una sostanziale impunità e, quel che è peggio, possono non lasciare né un segno visibile nel discorso pubblico né, contro i colpevoli, alcun provvedimento delle amministrazioni coinvolte in quella vergogna. Il vuoto legislativo consentirà a tutti di dimenticare che la tortura non è cosa «degli altri», di quelli che pensiamo essere «peggio di noi». Quel "buco" ci permetterà di trascurare che la tortura ci può appartenere. Che - per tre giorni - ci è già appartenuta.
* * *
Nella prima Magna Carta - 1225 - c´era scritto: «Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, spossessato della sua indipendenza, messo fuori legge, esiliato, molestato in qualsiasi modo e noi non metteremo mano su di lui se non in virtù di un giudizio dei suoi pari e secondo la legge del paese». Nella nostra Costituzione, 1947, all´articolo 13 si legge: «La libertà personale è inviolabile. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà»* * *
La caserma di Bolzaneto oggi non è più quella di ieri. Con un´accorta gestione, si sono voluti cancellare i «luoghi della vergogna», modificarne anche gli spazi, aprire le porte alla città, alle autorità cittadine, civili, militari, religiose coltivando l´idea di farne un "Centro della Memoria" a ricordo delle vittime dei soprusi. C´è un campo da gioco nel cortile dove, disposti su due file, i "carcerieri" accompagnavano l´arrivo dei detenuti con sputi, insulti, ceffoni, calci, filastrocche come «Chi è lo Stato? La polizia! Chi è il capo? Mussolini!», cori di «Benvenuti ad Auschwitz». Dov´era il famigerato «ufficio matricole» c´è ora una cappella inaugurata dal cardinale Tarcisio Bertone e nei corridoi, dove nel 2001 risuonavano grida come «Morte agli ebrei!», ha trovato posto una biblioteca intitolata a Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume italiana, ucciso nel campo di concentramento di Dachau per aver salvato la vita a 5000 ebrei.* * *
Quel giorno, era venerdì 20 luglio, l´ambiente è diverso e il clima di piombo. Dopo il cancello e l´ampio cortile, i prigionieri sono sospinti verso il corpo di fabbrica che ospita la palestra. Ci sono tre o quattro scalini e un corridoio centrale lungo cinquanta metri. È qui il garage Olimpo. Sul corridoio si aprono tre stanze, una sulla sinistra, due sulla destra, un solo bagno. Si è identificati e fotografati. Si è costretti a firmare un prestampato che attesta di non aver voluto chiamare la famiglia, avvertire un avvocato. O il consolato, se stranieri (agli stranieri non si offre la traduzione del testo). A una donna, che protesta e non vuole firmare, è mostrata la foto dei figli. Le viene detto: «Allora, non li vuoi vedere tanto presto…». A un´altra che invoca i suoi diritti, le tagliano ciocche di capelli. Anche H.T. chiede l´avvocato. Minacciano di «tagliarle la gola». M.D. si ritrova di fronte un agente della sua città. Le parla in dialetto. Le chiede dove abita. Le dice: «Vengo a trovarti, sai». Poi, si è accompagnati in infermeria dove i medici devono accertare se i detenuti hanno o meno bisogno di cure ospedaliere. In un angolo si è, prima, perquisiti - gli oggetti strappati via a forza, gettati in terra - e denudati dopo. Nudi, si è costretti a fare delle flessioni «per accertare la presenza di oggetti nelle cavità». Nessuno sa ancora dire quanti sono stati i "prigionieri" di quei tre giorni e i numeri che si raccolgono - 55 "fermati", 252 "arrestati" - sono approssimativi. Meno imprecisi i «tempi di permanenza nella struttura». Dodici ore in media per chi ha avuto la "fortuna" di entrarvi il venerdì. Sabato la prigionia "media" - prima del trasferimento nelle carceri di Alessandria, Pavia, Vercelli, Voghera - è durata venti ore. Diventate trentatré la domenica quando nella notte tra 1.30 e le 3.00 arrivano quelli della Diaz, contrassegnati all´ingresso nel cortile con un segno di pennarello rosso (o verde) sulla guancia.* * *
È saltato fuori durante il processo che la polizia penitenziaria ha un gergo per definire le «posizioni vessatorie di stazionamento o di attesa». La «posizione del cigno» - in piedi, gambe divaricate, braccia alzate, faccia al muro - è inflitta nel cortile per ore, nel caldo di quei giorni, nell´attesa di poter entrare «alla matricola». Superati gli scalini dell´atrio, bisogna ancora attendere nelle celle e nella palestra con varianti della «posizione» peggiori, se possibile. In ginocchio contro il muro con i polsi ammanettati con laccetti dietro la schiena o nella «posizione della ballerina», in punta di piedi. Nelle celle, tutti sono picchiati. Manganellate ai fianchi. Schiaffi alla testa. La testa spinta contro il muro. Tutti sono insultati: alle donne gridato «entro stasera vi scoperemo tutte»; agli uomini, «sei un gay o un comunista?» Altri sono stati costretti a latrare come cani o ragliare come asini; a urlare: «viva il duce», «viva la polizia penitenziaria». C´è chi viene picchiato con stracci bagnati; chi sui genitali con un salame, mentre steso sulla schiena è costretto a tenere le gambe aperte e in alto: G. ne ricaverà un «trauma testicolare». C´è chi subisce lo spruzzo del gas urticante-asfissiante. Chi patisce lo spappolamento della milza. A.D. arriva nello stanzone con una frattura al piede. Non riesce a stare nella «posizione della ballerina». Lo picchiano con manganello. Gli fratturano le costole. Sviene. Quando ritorna in sé e si lamenta, lo minacciano «di rompergli anche l´altro piede». Poi, gli innaffiano il viso con gas urticante mentre gli gridano. «Comunista di merda». C´è chi ricorda un ragazzo poliomielitico che implora gli aguzzini di «non picchiarlo sulla gamba buona». I.M.T. lo arrestano alla Diaz. Gli viene messo in testa un berrettino con una falce e un pene al posto del martello. Ogni volta che prova a toglierselo, lo picchiano. B.B. è in piedi. Gli sbattono la testa contro la grata della finestra. Lo denudano. Gli ordinano di fare dieci flessioni e intanto, mentre lo picchiano ancora, un carabiniere gli grida: «Ti piace il manganello, vuoi provarne uno?». S.D. lo percuotono «con strizzate ai testicoli e colpi ai piedi». A.F. viene schiacciata contro un muro. Le gridano: «Troia, devi fare pompini a tutti», «Ora vi portiamo nei furgoni e vi stupriamo tutte». S.P. viene condotto in un´altra stanza, deserta. Lo costringono a denudarsi. Lo mettono in posizione fetale e, da questa posizione, lo obbligano a fare una trentina di salti mentre due agenti della polizia penitenziaria lo schiaffeggiano. J.H. viene picchiato e insultato con sgambetti e sputi nel corridoio. Alla perquisizione, è costretto a spogliarsi nudo e «a sollevare il pene mostrandolo agli agenti seduti alla scrivania». J.S., lo ustionano con un accendino.Ogni trasferimento ha la sua «posizione vessatoria di transito», con la testa schiacciata verso il basso, in alcuni casi con la pressione degli agenti sulla testa, o camminando curvi con le mani tese dietro la schiena. Il passaggio nel corridoio è un supplizio, una forca caudina. C´è un doppia fila di divise grigio-verdi e blu. Si viene percossi, minacciati.
In infermeria non va meglio. È in infermeria che avvengono le doppie perquisizioni, una della polizia di Stato, l´altra della polizia penitenziaria. I detenuti sono spogliati. Le donne sono costrette a restare a lungo nude dinanzi a cinque, sei agenti della polizia penitenziaria. Dinanzi a loro, sghignazzanti, si svolgono tutte le operazioni. Umilianti. Ricorda il pubblico ministero: «I piercing venivano rimossi in maniera brutale. Una ragazza è stata costretta a rimuovere il suo piercing vaginale con le mestruazioni dinanzi a quattro, cinque persone». Durante la visita si sprecano le battute offensive, le risate, gli scherni. P.B., operaio di Brescia, lo minacciano di sodomizzazione. Durante la perquisizione gli trovano un preservativo. Gli dicono: «E che te ne fai, tanto i comunisti sono tutti froci». Poi un´agente donna gli si avvicina e gli dice: «È carino però, me lo farei». Le donne, in infermeria, sono costrette a restare nude per un tempo superiore al necessario e obbligate a girare su se stesse per tre o quattro volte. Il peggio avviene nell´unico bagno con cesso alla turca, trasformato in sala di tortura e terrore. La porta del cubicolo è aperta e i prigionieri devono sbrigare i bisogni dinanzi all´accompagnatore. Che sono spesso più d´uno e ne approfittano per "divertirsi" un po´. Umiliano i malcapitati, le malcapitate. Alcune donne hanno bisogno di assorbenti. Per tutta risposta viene lanciata della carta da giornale appallottolata. M., una donna avanti con gli anni, strappa una maglietta, «arrangiandosi così». A.K. ha una mascella rotta. L´accompagnano in bagno. Mentre è accovacciata, la spingono in terra. E.P. viene percossa nel breve tragitto nel corridoio, dalla cella al bagno, dopo che le hanno chiesto «se è incinta». Nel bagno, la insultano («troia», «puttana»), le schiacciano la testa nel cesso, le dicono: «Che bel culo che hai», «Ti piace il manganello». Chi è nello stanzone osserva il ritorno di chi è stato in bagno. Tutti piangono, alcuni hanno ferite che prima non avevano. Molti rinunciano allora a chiedere di poter raggiungere il cesso. Se la fanno sotto, lì, nelle celle, nella palestra. Saranno però picchiati in infermeria perché «puzzano» dinanzi a medici che non muovono un´obiezione. Anche il medico che dirige le operazioni il venerdì è stato «strattonato e spinto». Il giorno dopo, per farsi riconoscere, arriva con il pantalone della mimetica, la maglietta della polizia penitenziaria, la pistola nella cintura, gli anfibi ai piedi, guanti di pelle nera con cui farà poi il suo lavoro liquidando i prigionieri visitati con «questo è pronto per la gabbia». Nel suo lavoro, come gli altri, non indosserà mai il camice bianco. È il medico che organizza una personale collezione di «trofei» con gli oggetti strappati ai "prigionieri": monili, anelli, orecchini, «indumenti particolari». È il medico che deve curare L.K.
A L.K. hanno spruzzato sul viso del gas urticante. Vomita sangue. Sviene. Rinviene sul lettino con la maschera ad ossigeno. Stanno preparando un´iniezione. Chiede: «Che cos´è?». Il medico risponde: «Non ti fidi di me? E allora vai a morire in cella!». G.A. si stava facendo medicare al San Martino le ferite riportate in via Tolemaide quando lo trasferiscono a Bolzaneto. All´arrivo, lo picchiano contro un muretto. Gli agenti sono adrenalinici. Dicono che c´è un carabiniere morto. Un poliziotto gli prende allora la mano. Ne divarica le dita con due mani. Tira. Tira dai due lati. Gli spacca la mano in due «fino all´osso». G.A. sviene. Rinviene in infermeria. Un medico gli ricuce la mano senza anestesia. G. A. ha molto dolore. Chiede «qualcosa». Gli danno uno straccio da mordere. Il medico gli dice di non urlare. Per i pubblici ministeri, «i medici erano consapevoli di quanto stava accadendo, erano in grado di valutare la gravità dei fatti e hanno omesso di intervenire pur potendolo fare, hanno permesso che quel trattamento inumano e degradante continuasse in infermeria».
* * *
Non c´è ancora un esito per questo processo (arriverà alla vigilia dell´estate). La sentenza definirà le responsabilità personali e le pene per chi sarà condannato. I fatti ricostruiti dal dibattimento, però, non sono più controversi. Sono accertati, documentati, provati. E raccontano che, per tre giorni, la nostra democrazia ha superato quella sempre sottile ma indistruttibile linea di confine che protegge la dignità della persona e i suoi diritti. È un´osservazione che già dovrebbe inquietare se non fosse che - ha ragione Marco Revelli a stupirsene - l´indifferenza dell´opinione pubblica, l´apatia del ceto politico, la noncuranza delle amministrazioni pubbliche che si sono macchiate di quei crimini appaiono, se possibile, ancora più minacciose delle torture di Bolzaneto. Possono davvero dimenticare - le istituzioni dello Stato, chi le governa, chi ne è governato - che per settantadue ore, in una caserma diventata lager, il corpo e la «dimensione dell´umano» di 307 uomini e donne sono stati sequestrati, umiliati, violentati? Possiamo davvero far finta di niente e tirare avanti senza un fiato, come se i nostri vizi non fossero ciclici e non si ripetessero sempre «con lo stesso cinismo, la medesima indifferenza per l´etica, con l´identica allergia alla coerenza»?Repubblica 17.3.08
Londra: "Schedare Dna dei bimbi a rischio delinquenza"
LONDRA - Schedare il Dna dei bambini delle scuole elementari, il cui comportamento indica che potrebbero diventare delinquenti da grandi: è la proposta di un esperto di Scotland Yard, per far fronte alla crescente criminalità in Gran Bretagna. Secondo Gary Pugh, direttore di scienze forensi di Scotland Yard, è necessario aprire un dibattito su come poter identificare il prima possibile i potenziali delinquenti. Nella banca-dati del Regno Unito ci sono i dati di 4,5 milioni di individui, ma la polizia ritiene che ancora non sia sufficiente. «Il numero di delitti che rimangono insoluti indica che non abbiamo le tracce genetiche di un numero sufficiente di persone».
Repubblica 17.3.08
Renoir. I preziosi tesori impressionisti
Al Complesso del Vittoriano a Roma la grande rassegna "La maturità tra classico e moderno"
Alla fine degli anni Ottanta il suo viaggio in Italia da Venezia fino in Sicilia
Già nel 1869 dipingeva fianco a fianco a Monet sulle rive della Senna
Aveva sposato con entusiasmo la causa di quella che all´inizio fu detta "nuova pittura"
ROMA. Al Complesso del Vittoriano s´è aperta la mostra "Renoir. La maturità tra classico e moderno" (a cura di Kathleen Adler, catalogo Skira): e già il primo giorno d´apertura al pubblico, lunghe file all´ingresso preannunciano un successo dell´esposizione, come è d´obbligo per uno dei maggiori nomi dell´impressionismo. Centotrenta opere, fra le quali oltre sessanta dipinti, affiancati da disegni, incisioni e qualcuna (per fortuna non troppe) fra le ultime sculture eseguite in collaborazione con Richard Guino, si stringono nello spazio espositivo, di recente ampliato. La mostra è dunque vasta, e si avvale di prestiti provenienti da molti musei internazionali; nonostante ciò, essa è ben lungi dall´essere la mostra in grado di rappresentare congruamente il tema del rapporto che legò il Renoir post-impressionista all´idea del classico e del museo. Fatalmente, occorre dire, giacché a rappresentarlo idoneamente, quel grande tema, un´esposizione non può fare a meno di presentare opere - come Madame Charpentier e i figli o La bagnante bionda, Gli ombrelli o I bambini a Wagermont, per finire con le Grandi bagnanti di Filadelfia - che sono le bandiere che il Renoir orgogliosamente ingresque, devoto alla composizione e al disegno, innalzò nei suoi magici anni Ottanta. Opere tutte, d´altronde, che non sono di fatto oggi spostabili, e che - se mai lo fossero - non andrebbero altro che a una mostra organizzata dai musei nazionali francesi, da Londra o da New York.
Renoir aveva sposato con entusiasmo la causa della "nuova pittura", come fu detta, prima di prendere fra mille dubbi il nome con cui sarà più nota, la pittura impressionista. Già alla fine degli anni Sessanta, dipingeva fianco a fianco a Monet sulle rive della Senna, alla Grenouillère, luogo di gite domenicali della borghesia parigina sotto l´Impero di Napoleone III: e ritraeva con l´amico i riflessi mobili della luce sull´acqua, e le acconciature delle signore che si confondevano nell´atmosfera. Poi aveva partecipato alla prima mostra (1874, dal fotografo Nadar) dei futuri impressionisti: e di lì in avanti, per un pugno d´anni, aveva dipinto capolavori indimenticabili - Il palco, Sentiero che sale tra l´erba, L´altalena - in cui la luce, scendendo dall´alto, lenta e trepida, spesso attraverso una fronda di verzura, bagnava le cose togliendo loro, con la nitidezza dei contorni, il peso e la fatica dell´esistenza.
Sul finire degli anni Settanta, però, la solidarietà che aveva stretto l´animo e l´azione dei giovani impressionisti va rapidamente scemando: e, per ragioni prevalentemente strategiche, l´uno dopo l´altro si sottrarranno alle esposizioni di gruppo, che proseguiranno con sempre minor entusiasmo fino al 1886. Una fra le ragioni delle prime defezioni risale al 1878: quando Degas riuscì a far approvare la determinazione che rendeva inconciliabile l´invio contemporaneo di opere al Salon ufficiale e alle mostre impressioniste. Renoir fu il primo, allora, a scegliere la grande manifestazione dell´Accademia, condividendo la convinzione che era stata sempre di Manet, che «si vinca o si perda solo al Salon»; inviò già all´edizione del 1879, e in quella successiva ottenne uno strepitoso successo con il quadro di grandi dimensioni raffigurante una signora dell´alta borghesia, Madame Charpentier, circondata dai suoi figli e dalle stoffe, dai tappeti, dai mobili del suo salotto.
Quel dipinto, che pur ancora rinserrava piccoli tesori "impressionisti" soprattutto nei volti e nelle vesti delle due piccole figlie, aveva un sapore d´antico: per le sue grandi dimensioni, per la studiatissima composizione, per la sua ordinata spazialità, per l´analisi degli "affetti" che vi si legge. Renoir vi ripercorreva esplicitamente la tradizione accademica del "ritratto di famiglia in un interno". Il successo che ottenne lo convinse che la conversione alla nuova forma era la via da perseguire; e non appena le condizioni economiche glielo consentirono, egli intraprese quel viaggio in Italia che, riconducendolo alle fonti dell´arte classica, era in grado di nutrirne l´inclinazione a rivisitare il più illustre passato della pittura. Fu in Italia alla fine del 1881. Partì da Venezia e arrivò sino in Sicilia, dove ritrasse Wagner che vi aveva appena portato a compimento il Parsifal (una replica di questo celebre dipinto è oggi in mostra a Roma). E nel febbraio dell´anno seguente, appena rientrato in Francia, scriveva dall´Estaque, dove s´era fermato a rendere visita a Cézanne, proprio a Madame Charpentier del «museo di Napoli», delle «pitture di Pompei» e di Raffaello, concludendo che «guardando molto, credo potrei conquistare la grandezza e la semplicità dei pittori antichi».
Da lì in avanti, disseminati per il decennio, sarebbero venuti i dipinti con cui Renoir riformava se stesso e i suoi anni, diversamente meravigliosi, della giovinezza impressionista. La mostra di oggi li ripercorre, con le inevitabili lacune di cui s´è detto, ma anche con soste preziose (La zingarella, del 1879; Il bagno della Thyssen-Bornemisza; la Donna con fiocco bianco del museo de Il Cairo; il Ritratto di Paul Haviland di Kansas City; le Fanciulle al piano di Omaha).
E va oltre, a cercare nell´età tarda ed estrema quella nuova dissoluzione della forma salda e chiusa del tempo "classico" che caratterizzò gli ultimi anni del pittore, e che fu certo guardata dal Picasso "mediterraneo" al transito fra anni Dieci e anni Venti del nuovo secolo.
il Riformista 17.3.08
Un paese che ha politici che non urlano
Zapatero vince perchè ci crede fino in fondo
di Tiziana Santarsia
Caro Costanzo, sono un'italiana che vive in Spagna da poco più di un anno e, strano ma vero, "ho incontrato Zapatero" si, è proprio così; questa estate mi trovavo a Sanlucar de Barrameda, il "pueblo" sulle foci del Guadalquivir da dove Colombo salpò più volte per i suoi viaggi verso le americhe. Ci avevano consigliato un posticino dove gustare, tra le tante "tapas" tipiche, le tortillas de cammarones. Giunti sul posto, notammo subito che l'assembramento di gente e lo spiegamento di forze pubbliche e cameraman non era né per noi né per le tortillas. Il Presidente arrivò poco dopo tra le ali della folla curiosa e accaldata, si sedette al suo tavolino blindato della modesta taverna e gustò le fumanti tapas; si lasciò riprendere da telefonini, dalle macchine fotografiche dei turisti, si fece abbracciare dalle anziane signore di paese e firmò autografi come da copione. Capii ben presto che non si trattava di una visita di piacere nè di una visita istituzionale, ma che ci trovavamo di fronte a quello che probabilmente era l'inizio della campagna elettorale.
Zapatero era tornato in Andalusia, tra gli elettori che avevano contribuito più di chiunque altro alla sua vittoria nel 2004 per chiedere nuovamente il loro appoggio.
Oggi, alla luce della sua rielezione a capo della Spagna, mi chiedo perché la gente lo ha scelto ancora? Ha forse indovinato la chiave di lettura per una campagna elettorale vincente, o gli spagnoli si sono invaghiti di lui e delle sopracciglia a punta?
La mia non vuol essere una domanda sarcastica dettata dalla necessità di schierarsi a favore o contro, ma è la pura curiosità di chi, alle soglie delle ennesime elezioni in Italia, legge negli occhi e nelle parole dei suoi connazionali tanta incertezza, disorientamento, disillusione e quant'altro.
A parte gli "irriducibili" dei vari schieramenti, mi chiedo quante persone in Italia siano veramente interessate a ciò che dicono i politici. E va bene che anche in politica, come in amore, c'è il gioco delle parti ed ognuno ha il suo ruolo da rispettare. Ma c'è modo e modo: e la comunicazione ha comunque delle regole, un'etica. Non possiamo sempre passare per quelli che fanno spettacolo; persino la gente del paesino dove vivo mi dice "….ah sì, i politici italiani, quelli che si insultano in Parlamento!".
Senza entrare nel merito politico, mi è sembrato che il clima pre-elettorale che si è respirato qui fosse più civile ed improntato alla comunicabilità di un preciso messaggio, quale che esso fosse.
Nel corso dei mesi che hanno preceduto le elezioni ho seguito sommariamente la campagna di Zapatero. Ma so per certo che è stata capillare nel territorio e mirata soprattutto a convincere: a) i suoi sostenitori a dargli la possibilità di continuare, "rispettando il suo programma", sulla strada delle riforme intrapresa nella passata legislatura, e b) parlare con gli indecisi e gli scontenti, per convincerli che tanto ancora si poteva fare per rafforzare la presenza spagnola in una Europa sempre più esigente, a fronte degli innegabili dati di crescita registrati.
Zapatero si è concentrato sulle fasce sociali, per così dire, più deboli e quindi più sensibili, convincendole che la qualità della vita dei cittadini avrebbe continuato ad essere una priorità nel suo governo. E l'ondata di riforme civili che si sono attuate hanno dato forza e peso alle sue parole. Difatti le zone nelle quali il suo partito ha ottenuto il maggior numero di voti sono quelle meno industrializzate e con i maggiori problemi di disoccupazione. Inoltre, ha accontentato gli animi federalisti aumentando le autonomie delle Comunidad (regioni)
Ha martellato i suoi sostenitori dicendo loro che, per governare bene, era necessaria la maggioranza assoluta, per non scendere a compromessi e stringere strane alleanze (e noi italiani ne sappiamo qualcosa).
Insomma "Zp" (zepe), come lo chiamano qui, si è presentato come un abile comunicatore e stratega, carismatico ed anche di bell'aspetto, il che non guasta mai. Nella sua campagna fin dall'inizio ha mostrato serenità, autoironia e sicurezza di sé e delle azioni del suo governo, senza mai eccedere nell'attacco diretto e denigratorio al proprio rivale.
Più volte ha ripetuto che "molte sono le cose ancora da risolvere, ma molte altre da celebrare. Mi piace il paese in cui viviamo, e mi piace la Spagna di oggi ". Una frase stata studiata a tavolino, sta di fatto che ha centrato il suo obiettivo.
E non posso che dargli ragione. Sfido qualsiasi politico italiano, di destra o di sinistra, a dire una cosa del genere e a non essere linciato.
Io da straniera mi ritrovo in una realtà decisamente vivibile (trasporti che funzionano, sanità accettabile, infrastrutture efficienti ecc.), che credo di non poter ritrovare in questo momento in Italia. Nonostante viva nel profondo sud della Spagna.
Secondo me Zapatero ha saputo vendere bene la propria immagine, riscuotendo gradimenti anche all'estero. Spesso si è mostrato con abbigliamento informale, sorridente e rilassato, ed ha assunto un atteggiamento confidenziale con gli elettori mirando, come lui stesso diceva, ad accorciare le distanze tra la politica ed i cittadini. Il tutto in contrapposizione ad un Rajoi (l'avversario conservatore) ancora troppo ingessato nel suo stereotipo di politico tradizionale, serio e spesso poco incisivo, anche se molto preparato e con solide argomentazioni.
Dopo 15 anni per la prima volta i candidati premier dei due partiti più importanti si sono mostrati alla nazione in due faccia a faccia televisivi creando un evento mediatico forse esagerato rispetto a quelli che sono stati poi i contenuti dei botta e risposta, rigorosamente preparati, che però per due sere ha catalizzato l'attenzione di molti milioni di spettatori ed elettori (altro che festival di Sanremo).
Certo, questo non è il paese delle meraviglie, anche qui non mancano controsensi e "buchi neri", ma almeno qui i politici non urlano e non s'insultano …… per non dire altro.
il Riformista 17.3.08
Total Audience. Un nuovo Verbo per confondere il mercato
Il Gruppo L'Espresso rischia di contare le mele con le pere
di Marco Barbieri
Con l'abituale ritardo rispetto ai mercati veri, anche l'editoria italiana sta importando le nuove parole d'ordine, con il rischio di aderire agli slogan, senza dotarsi degli strumenti adeguati a trasformarsi. E come al solito non sa nemmeno tradurli. "Total audience" è il verbo. Che avrebbe un senso, eccome. La stampa ha bisogno di dimostrare - cosa che probabilmente è anche vera - che buona parte dei contatti utili a livello pubblicitario si sono trasferiti sul Web. O perlomeno l'uno e l'altro mezzo costituiscono una efficace integrazione.
Mentre si discuteva di quale fosse il modello di business più efficace per rendere redditizia la grande Rete, negli Stati Uniti, così come nel Regno Unito, si procedeva pragmaticamente per tentativi. Il "New York Times" riduce progressivamente i suoi accessi a pagamento, convinto che l'uso gratuito delle sue notizie diffuse sui siti, sia sufficiente a equilibrare i conti, secondo la vecchia legge tv: raccolgo teste (o con l'intrattenimento o con le news) per poi rivenderle come contatti agli utenti pubblicitari. E la Bbc scopre che in una settimana sul suo sito raccoglie più utenti di quanti spettatori abbiano seguito i singoli programmi tv negli ultimi cinque anni.
E allora? Copiamo. Tra i primi, un anno e mezzo fa, il Gruppo Espresso aveva commissionato uno studio a Eurisko per dimostrare l'esistenza di un nuovo "medium", che nasceva dalla combinazione del quotidiano "la Repubblica" e dal sito Web: 8 milioni di contatti al giorno (circa 6 quelli del cartaceo, circa 2 quelli online, allora: oggi sono quasi 3 milioni). Poche settimane fa Marco Benedetto ha ribadito l'obiettivo, estendendolo a tutti i prodotti del gruppo: non solo quotidiano (meglio: quotidiani) e Web, ma anche il settimanale ("l'Espresso", più gli altri periodici), le radio, le tv. Ogni settimana oltre il 50% della popolazione italiana, circa 33 milioni di individui, si mette in contatto con almeno un mezzo o un veicolo del Gruppo Espresso.
Insomma, ecco la nuova frontiera. Dichiarata ormai anche da Rcs. E gli altri grandi gruppi editoriali non saranno da meno. A parole. Già, a parole. Perché la questione è passare dalla parole ai fatti. E i fatti sono spesso composti di numeri. Dati, cifre. Per i quali l'Italia e gli italiani hanno una consolidata idiosincrasia. E il mercato pubblicitario per anni ha offerto una accondiscendente opacità, vinta solo da qualche eccellenza che non ha fatto scuola.
In questi giorni di campagna elettorale i maggiori istituti di ricerca di mercato e di opinione sfornano previsioni e sondaggi. Magari arrivando - una vera assurdità - a polemizzare con alcuni loro committenti (i partiti o gli editori) perché esagererebbero nell'uso dei loro numeri. Peccato che per le società in questioni la continua campagna elettorale italiana costituisca un'occasione unica di pubblicizzazione dei loro marchi e dei loro servizi. Ciononostante la propensione all'investimento in ricerche di mercato e sondaggi di opinione è in Italia assai sotto la media europea. Spendono poco le aziende. Spende pochissimo la Pubblica amministrazione. Non ci sono serie storiche, non ci sono numeri condivisi. E soprattutto sul fronte dell'editoria.
La storia recente di Audipress merita silenzi e non commenti. Le certificazioni di Ads (accertamenti sulle diffusioni) sono più utili ai contributi pubblici sulla carta, che a monitorare il mercato dell'editoria. In questo contesto sentire parlare di "total audience" può essere motivo di speranza o di sconforto. Speranza di poterci avvicinare alle tanto vituperate pratiche di quantificazione con cui la tv (Auditel sarà il mostro che è, ma almeno è uno strumento che funziona) ha abituato la sua utenza pubblicitaria. Sconforto? Sì, il rischio è che sotto una mano di belletto - nominalistico o di procedura - si continui a voler nascondere i numeri della carta stampata dietro quelli incontrovertibili del Web. Ma di nuovo confondendo il mercato con un improbabile somma di mele e pere.